Scritti
-
Why do architects still draw?
-
Il fattore T
-
Sotto/Sopra
-
Nulla dies sine linea
-
Laboratorio Italia
-
Why Architects Still Draw
-
Kultur-Fabrik-Perugia
-
L'amnesia del presente
-
Una lezione insolita
-
Accumulazioni caotiche
-
Artefatti insoliti
-
Felix Infortunium
-
La vitalità delle strade
-
La rappresentazione della complessità/La complessità della rappresentazione
-
Il disegno della forma urbana
-
Brouillons d'Architects
-
The nursery school "Dr. Senatore Borletti" by Marco Zanuso in Gubbio
Paolo Belardi
Why do architects still draw?
Interview with Paolo Belardi by Max Grinnell in “The Urbanologist”, http://theurbanologist.com/post/93311675301/why-do-architects-still-draw, [30/07/2014]
Paolo Belardi recently wrote the compelling work "Why Architects Still Draw?" (MIT Press) and it’s a thoughtful read on why dedication to this basic skill is a font for creativity, meditation, and serendipity. He responded to my queries below and you’ll find that his responses are also creative and meditative.
In your introduction, you talk about training architects who know both technical skills and have a certain sense of culture. Have these worlds grown so far apart in the training of architects?
For anyone who works in architecture, the culture dimension is is so fundamental that you can’t do without it—though today it tends to be overwhelmed by digital techniques. This above all when you draw, because the eye sees what the mind knows. It’s not a coincidence that the more thing we know, the more things we see. The beauty of a landscape, for example, doesn’t exist in and of itself but rather is a mental construction that we perceive only after someone has revealed it to us, and only after we’ve made it our own after study. In other words, the beauty of a landscape is not a cause but rather an effect of the culture of the observer.
In his Italian Journey, Johann Wolfgang Goethe, arriving at the gates of Rome, confesses to not feel free in his judgment of what he will see, as he feels conditioned by the knowledge of the ancient classics. Just the same today—keeping in mind the fundamental role played by cinematographic production in the field of defining the identity of places—when we have to ask ourselves what the idea of the Eternal City is for foreigners. Is it the one of the cursed heroes of Pier Paolo Pasolini, the intrusive paparazzi of Federico Fellini, the solemn balance of Peter Greenaway, or the banal lies of Paolo Sorrentino?
You speak of the importance of serendipity in architecture, and more broadly, in the time we have on this Earth. What are the moments in which we can feel the closest connection to the built environment? Might you share with me a couple recent “Eureka” moments
I’m used to drawing a lot and without immediate goals (especially during boring business meetings) so that later I can page through my notebooks and feed my figurative repertoire with a healthy, creative misunderstanding. It’s perhaps the most effective technique for planning serendipity through an “emotional push” that only imperfect comprehension can give to the act of imagining. In that sense, my creativity (if I have any) is cultivated in a continuous way, not sudden Eurekas.
That said, there was one moment where I was present at a Eureka moment. It was when I involved Wolf Prix, the leader of a Viennese studio called Himmelb(l)au, in the project to cover a street made in the sixteenth century by the great architect Galeazzo Alessi in the heart of Perugia, the city where I live and work. Prix didn’t know Perugia at all, only by the graphic and photographic documentation I had sent him via email. Despite that, when he got to the place and sat down at a café table for a caffè americano, he grabbed a napkin and—in just a few seconds—sketched out the idea for the project. It was a helix à la Leonardo that wouldn’t just protect the street from the weather, but would also produce the energy necessary to sustain itself with the wind and the sun.
Has there ever been a moment where you were without pencil and paper and thought “Drat, I wish I had captured that.” Can you give us an example or two?
Yes, when my daughter Angelica (now eleven years old) was born. Knowing that I would be there for the birth, I did what all fatehrs do: I got a videocamera. But when my daughter’s head emerged from my wife’s body, I felt the powerful desire to capture a moment that in a certain way is miraculous. It’s a moment when happiness and pain are one and which, for a second, I felt linked in an ideal way to humanity. A few years ago the artist Marni Kotak gave birth to her first son in a New York art gallery to a crowd of onlookers. She justified her performance by affirming that “giving birth to a baby is the most direct testimony of the creative force of life and, therefore, the highest form of art” though she was roundly criticized as being an exhibitionist. Personally I think that the reality show dreamed up by Kotak was right on.
During your travels in the United States, have you ever found any buildings or sections of the built environment that speak to your own personal preferences as an architect?
I’ve traveled widely in the States, along with my students. Inevitably, I was impressed by New York precisely because there is no space, and by Los Angeles because it’s so difficult to orient oneself there. But I was even more impressed by the lighthouses on the coast of New England, by the covered bridges in Quebec, and by the colonial-style houses in Florida. To be even more specific, I was moved by two environmental conditions that were complete opposites, but which open the doors of architecture in the third millennium: one hung towards the heaven and the other sinking into the earth. I’m talking about the ancient Acoma Pueblo, better known as Sky City because of its dominant position on the peak of a mesa in New Mexico, and the underground addition to the law school designed by Gunnar Birkerts on the campus of the University of Michigan.
Is there a city that you have yet to visit which you would like to map and explore with your mind, pencil, and a sketchbook?
Precisely because they have not yet been founded and not yet discovered, I would like to have the privilege of walking through the “invisible cities” that are the protagonists of the work of the same name by Italo Calvino. I’m thinking here of Laudomia, the “double city”, and of Melania, “the city of dialogue”, or Zoe “the city of indivisible existence”. Of course it would be a trip bumped by the difficulties of perspective, but it would be worth it. At the end of it I could draw a magical atlas like Marco Polo gave to Kublai Khan, the emperor of the Tartars, in which the invisible had been rendered visible by drawing.
There is much fetishizing of signature architecture landmarks (the Colosseum, Burj Khalifa and others) What can close explorations of those everyday, hum-drum, quotidian buildings tell us? The common post office? A low-slung suburban mall? Or others?
Architecture is the art of the real world. Consequently the quality of a city, much more than signature architecture landmarks, depends on the diffused character of anonymous normality. This is even more apparent in the era of sustainability, above all in Italy. It’s hard to deny that, paging through architectural magazines, it’s almost as if lightness, immateriality, and transparency capture by themselves the concept of sustainability. Just like it seems that a building covered with double-paned windows and equipped with photovoltaic panels is necessarily more sustainable that a building covered in cut stone. Nothing is more false.
It’s true that designing in a sustainable way means avoiding wasting natural resources and putting leftovers to good use, so it’s not hard to realize that the most sustainable complexes in the history of architecture are Italian city centers. They grew by implosion, minimizing the use of space, where each stone, each brick, each capital was not thrown out in some suburban junkyard but rather was reused to build on the already built: over, under, in the middle, and inside of the pre-existing structures. I’m thinking here of the Arch of Constantine in Rome and the Baptistery of Saint John in Florence, made of marble slabs from the ruin of some even more ancient building. It’s the same with the Cancello neighborhood in Formia: a Roman amphitheater that in the middle ages was converted into a huge apartment building. Because sustainability—for those of us who are children of Leon Battista Alberti and Donato Bramante—is not a chimera, but rather is part of our everyday life and work. And, as always, it’s a guarantor of personality and identity.
Interview translated from Italian by Zachary Nowak
Il fattore T
Il surplus estetico delle stratificazioni architettoniche
da Paolo Belardi, Il rilievo insolito. Irrilevabile, irrilevante, irrilevato, Quattroemme, 2001
"Uno dei più grossi lavori di quest’anno fu di scavare dall’alto in basso, a strati, una grossa massa di terra rimasta ancora intatta sul lato ovest e sud di Pergamo. Questo scavo aveva il massimo interesse per la scienza perché al centro dell’acropoli i Romani avevano distrutto le mura delle abitazioni dei più antichi strati superiori, per ottenere una piattaforma, mentre qui, fuori della Pergamo della seconda città, quella bruciata, e più vicino al muro dell’acropoli romana, le mura delle abitazioni sono conservate con le loro fondamenta per circa un metro di altezza in media. Esse presentano quattro insediamenti, che si sono susseguiti l’uno sull’altro dopo la rovina dell’ultima città preistorica, e ancora al di sotto, prima di raggiungere il terreno di base della seconda città, si trovano le mura delle abitazioni di altri tre insediamenti preistorici che si sono susseguiti l’uno sull’altro” (Heinrich Schliemann).
Quando guardiamo le architetture del passato, si tratti di una parte di città o anche più semplicemente di un singolo edificio, c’interessiamo prevalentemente della loro configurazione; nel senso che in genere è proprio la forma, e quindi l’immagine di un manufatto architettonico, al di là di qualsiasi ragione distributivo-strutturale, quella che percepiamo. Non solo. La forma che memorizziamo, almeno nei casi in cui le nostre attenzioni non comportano particolari intenzionalità analitiche, è per lo più quella attuale; come cioè la stessa si è venuta conformando, nel tempo, fino ai nostri giorni. Se ad esempio ci troviamo nella chiesa abbaziale di San Galgano, presso Siena, siamo colpiti dalla particolare condizione ipetrale e difficilmente ci poniamo il problema di ricostruire mentalmente la situazione spaziale originale. Ciò che al contrario ci emoziona è proprio l’eccezionalità della condizione diruta, con il pavimento erboso e i raggi solari filtranti attraverso le alte bifore della navata. Così come, nella loggia rinascimentale della basilica dei Santissimi Apostoli a Roma, il contrasto fra la dinamicità del primo ordine e il rigore dell’attacco a terra è determinato dalle alterazioni barocche dell’impianto originario, allorché, su disegno di Carlo Rainaldi, gli intercolunni del livello superiore vengono prima murati, quindi parzialmente sfondati con l’introduzione di ampie finestrature decorate e, infine, coronati con una balaustra di nuova invenzione. In entrambi i casi non interessa più di tanto il fatto che le due configurazioni formali sono state determinate da eventi assolutamente estranei alle intenzionalità progettuali originarie (lo smantellamento della copertura causato dalla negligenza dell’abate commendatario Girolamo Vitelli, nel caso dell’abbazia cistercense, e i lavori di ristrutturazione funzionale promossi dal cardinale Brancati di Lauria, nel caso della basilica romana): ciò che percepiamo e memorizziamo sono comunque le stratificazioni architettoniche finali sotto i nostri occhi (1). Stratificazioni architettoniche peraltro generate non solo da processi di costruzione, ma anche di decostruzione. Infatti, se la basilica dei Santissimi Apostoli si presenta come un sistema complesso di segni sovrapposti, che tradiscono lo sfogliamento progressivo della composizione originaria, la chiesa abbaziale di San Galgano trova forza espressiva proprio nella condizione di rudere (forse la più drammatica forma di decostruzione), in quanto l’unitarietà del manufatto architettonico di partenza è negato dalla decomposizione strutturale e, con essa, dal progressivo riassorbimento nel paesaggio naturale.
D’altra parte, consapevoli di come un’architettura stratificata comporti un grado di complessità e un’individualità non parimenti riscontrabile in un manufatto o comunque in una struttura urbana concepita unitariamente, avvertiamo, seppure inconsciamente, lo spessore dei pensieri sedimentati e siamo coinvolti proprio da quegli esempi in cui l’innovazione appare talmente debitrice alla situazione preesistente da risultare altrimenti gratuita; in un certo senso le stesse motivazioni che, in un passo de Il fauno di marmo di Nathaniel Hawthorne, spingono una comitiva di artisti anglo-americani, impegnati nella classica passeggiata romana al chiaro di luna, a deviare dal percorso diretto, dal Foro di Traiano al Colosseo, “per poter ammirare [...] il portico di un tempio dedicato a Minerva [...] all’interno del quale si è stabilito un macellaio, con l’ingresso aperto in un fianco” (2). Ansia di manierismo? Gusto del pittoresco? Forse, ma più ancora l’esigenza di marcare lo scarto fra collocazione e dislocazione, fra modello e invenzione; esigenza che, implicitamente, chiama in causa il concetto strutturalista di palinsesto e, con esso, quelle ambiguità architettoniche impreviste, in quanto non programmate nel progetto originario, che Robert Venturi definisce lucidamente “contraddizioni evidenziate” (3). Nel palazzo Tarugi di Montepulciano, ad esempio, la condizione d’angolo, involontariamente esaltata dall’occlusione funzionale del loggiato superiore, prevale sulla centralità dell’organismo concepito da Antonio da Sangallo il Vecchio? E ancora, nella basilica di San Venanzio a Camerino, il fuori scala è imputabile ai preziosismi del portale trecentesco o piuttosto all’ordine gigante del pronao neoclassico anteposto da Luigi Poletti nell’Ottocento? Mentre, all’opposto, proviamo una qualche estraneità rispetto ai manufatti architettonici rimasti immutati nel corso dei secoli: simulacri di una compiutezza che, in un certo senso, ci insospettisce e conferisce agli stessi un carattere più archeologico-museale che non schiettamente urbano. Basti pensare, ad esempio, alla ricostruzione del palazzo della Mercanzia di Bologna o, più ancora, all’integrità monotonale di interi centri storici cristallizzati nel tempo come Carcassonne e Toledo. Sappiamo bene, infatti, che una qualsiasi architettura, per assurgere a fatto urbano, deve necessariamente evolversi come struttura dialettica, assumendo un ruolo significante nell’ambito della geografia urbana non solo in virtù della mera permanenza topografica, ma anche e soprattutto a causa delle successive modificazioni indotte nel tempo. Avviene così che la concatenazione di esiti formali eterogenei, magari anche contraddittori, costituisce a buon diritto una categoria interpretativa autonoma, che di per sé prescinde qualsiasi catalogazione meramente stilistico-gerarchica e, di contro, propone un’ampia campionatura delle potenzialità integrative fra progetto e preesistenze. In questo senso l’oggetto del nostro interesse può essere rappresentato dal teatro Sanzio di Urbino (sovrapposto da Vincenzo Ghinelli nell’Ottocento al cinquecentesco torrione dell’Abbondanza di Francesco di Giorgio Martini) come dall’arena di Tarazona (edificata nel Settecento come plaza de toros e solo successivamente trasformato in quartiere popolare), dalla basilica di Santa Maria degli Angeli di Assisi (che ingloba la chiesetta della Porziuncola) come dal Partenone di Atene (a lungo convertito in moschea) (4). Consideriamo per un momento, in proposito, il caso emblematico del monastero di Santa Caterina, nel cuore Sinai: una struttura conventuale cresciuta intorno alla cappella fatta erigere nel IV secolo sul luogo del roveto ardente e che, nel tempo, ha assunto l’aspetto di una pittoresca cittadella fortificata in virtù di continue, quanto disinvolte, addizioni edilizie e, soprattutto, a seguito dell’erezione del recinto murario voluto dall’imperatore Giustiniano a protezione dalle scorrerie delle tribù nomadi. Considerata a sé, nessuna delle singole strutture architettoniche incorporate appare eccezionale, mentre è proprio la forte impressione trasmessa dall’insieme a giustificare la sensazione di trovarci di fronte a una microcittà: un vero e proprio palazzo-città che, pur in assenza di un disegno programmatico, presenta una straordinaria unitarietà compositiva, che in qualche modo incarna l’ideale estetico di Giacomo Leopardi quando, nello Zibaldone, sostiene che “al piacere contribuisce la varietà, l’incertezza, il non vedere tutto e il potersi perciò spaziare con l’immaginazione riguardo a ciò che non si vede […] – perché - il piacere dell’incertezza e della varietà prevale a quello dell’apparente infinità, e dell’immensa uniformità” (5). In questo senso la varietà, l’incertezza, il non vedere subito tutto, diventano la possibilità di accedere con l’immaginazione a ciò che non è visibile, riconoscendo una qualità intrinseca alle complicazioni indotte dai processi di modificazione.
Ma c’è dell’altro. Infatti è solo percorrendo le vie di uno qualsiasi dei centri storici europei che, grazie alla percezione del ritmo incalzante generato dalle irregolarità impreviste oltre che dai repentini cambiamenti di scala, riusciamo a convincerci di come tali eventi possono essere prodotti sempre e soltanto da quel lavoro collettivo cui Eisenman riconosce la capacità di conferire il crisma della intrasferibilità: Two pieces: the quarry and the palimpsest ... Now you take the stones and build one project. Someone else will take the stones from your project and buid something else ... We start from the palimpsest which is the superposition of two pieces which then becomes a quarry and then you subtract from the palimsest leaving the trace of the former superposition, but also the trace of the subtraction, so in other words we are talking about “chora”. The combination of the superposition of palimpsest and quarry gives you “chora” (6). In effetti, se un modello tipologico, in quanto coerente e unitario, può essere ragionevolmente riproposto anche in contesti diversi, non potremo mai trasferire integralmente, a meno di artificiose forzature, la climax pittoresca del rione San Pellegrino di Viterbo o le sovradiacenze del palazzo del Popolo di Ascoli Piceno, perché intimamente connesse e strutturate, nei processi combinatori dei diversi addendi, alle peculiarità dell’hic et nunc; così come nello sfondo del San Sebastiano di Andrea Mantegna, dove alcuni edifici classici in disfacimento, insieme a un acquedotto romano con i fornici utilizzati a botteghe e a un arco trionfale sopraelevato, disegnano uno spaccato architettonico in cui l’astratto rigore geometrico rinascimentale attinge forza espressiva proprio dalle complicazioni di una città costruita e decostruita pezzo per pezzo dal fattore T (tempo). Così, seppure non conferiremo mai sufficiente importanza alla complessità degli esiti finali e nonostante la città tenda a eludere i perimetri angusti di qualsiasi sovrastruttura critica artificiosamente imposta, appare comunque conveniente rilevare, organizzandola razionalmente, la sistematicità di processi formativi la cui oggettiva necessità è testimoniata proprio dalla ricorrenza in ambiti e culture profondamente lontane, sia temporalmente che geograficamente. Esemplificativa in proposito la celebre Veduta ideale di piazza italiana di Karl Friedrich Shinkel, un curioso montaggio eclettico in cui il sommo architetto prussiano, frantumando le barriere spazio-temporali, accosta con disinvoltura memorie archeologiche romane e pavimentazioni rinascimentali, le Procuratie e i dioscuri del Quirinale. Il risultato è uno scorcio urbano evidentemente immaginario, almeno nei suoi esiti formali, che tuttavia potrebbe sussistere realmente qualora, in qualche luogo, si fossero presentate le condizioni per il concretarsi di una tale contaminazione architettonica.
Nondimeno, dall’analisi di un qualsiasi fatto urbano, appare enucleabile, all’interno delle diverse sedimentazioni, una prima grande distinzione fra quelle modificazioni architettoniche che non comportano sensibili variazioni nell’inviluppo volumetrico delle preesistenze (Stratificazioni senza variazione di sagoma) e, all’opposto, quelle modificazioni architettoniche che comportano sostanziali alterazioni dello stesso (Stratificazioni con variazione di sagoma).
Risultando le Stratificazioni senza variazione di sagoma articolate in processi di:
- Metamorfosi (trasformazione interna da una organizzazione spaziale ad un’altra) ;
- Inglobamento/Inclusione (incorporazione di uno o più manufatti preesistenti o inserimento, all’interno di un corpo edilizio, di uno o più manufatti indipendenti);
- Trasferimento (scomposizione e ricostruzione, in nuovi contesti, di un intero manufatto architettonico).
Mentre all’interno delle Stratificazioni con variazione di sagoma appaiono enucleabili processi di:
- Addizione (accumulazione di interi corpi edilizi o di nuovi elementi architettonici intorno ad un nucleo originario);
- Sottrazione (rimozione, deliberata e non, di parti di un manufatto architettonico);
- Sovrapposizione (edificazione, superiormente al manufatto originario, di nuovi corpi edilizi).
Considerando poi che, come facilmente riscontrabile, la maggior parte delle architetture stratificate è riconducibile a combinazioni di volta in volta diverse, sia qualitativamente che quantitativamente, delle categorie dinamiche elementari sopra elencate, se non addirittura di tutte simultaneamente. Basti pensare ai casi emblematici del palazzo di Diocleziano a Spalato, dell’anfitetro di Nimes e della Rocca Paolina a Perugia. Laddove, nei primi due esempi, il palazzo imperiale e l’anfiteatro romano si trasformano spontaneamente in altrettanti nuclei cittadini; mentre, nel terzo, l’antico quartiere dei Baglioni viene convertito in fortezza papale da Antonio da Sangallo il Giovane che, con spirito antiquario, preserva parte del tessuto edilizio del colle Landone come sostruzione. Episodi architettonici, questi, così complessi e intricati da renderci pienamente coscienti del surplus estetico delle stratificazioni architettoniche; perché, da sempre, “le ferite di una città raccontano la sua storia meglio di qualsiasi libro o documento” (7).
Note
1 ”Esiste un altro luogo concettuale fondamentale [...] si tratta dell’idea di stratificazione. Se io osservo un disegno che mi restituisce la sovrapposizione di diverse giaciture di resti, ad esempio una planimetria del Foro Romano con in rosso le murature repubblicane, in giallo quelle del primo impero e in blu le tracce delle edificazioni del terzo secolo dopo Cristo, mi confronto con un’immagine che "visivamente" si presenta come un sistema di segni che si scompone nelle sue parti quasi per un percepibile movimento. Attraverso una sorta di accelerazione mentale posso letteralmente assistere allo "sfogliamento" progressivo di questo testo edilizio” (F. Purini, La forma storica della decostruzione nella architettura italiana, in B. Bottero (a cura di), Decostruzione in architettura e filosofia, Milano 1991, p. 53).
2 N. Hawthorne, Il fauno di marmo, Roma 1945, pp. 63-64.
3 R. Venturi, Complessità e contraddizioni nell’architettura, Bari 1980, pp. 69-84.
4 “É evidente che ogni cosa ha una sua funzione a cui deve rispondere ma la cosa non finisce lì perché le funzioni variano nel tempo. É stata sempre questa una mia affermazione di carattere scientifico che ho tratto dalla storia della città e dalla storia della vita dell’uomo: la trasformazione di un palazzo, di un anfiteatro, di un convento, di una casa e dei loro diversi contesti. Mi sono sempre riferito a questo parlando dei monumenti perché ho visto palazzi antichi abitati da molte famiglie, conventi trasformati in scuole, anfiteatri trasformati in campi da pallone e questo è sempre avvenuto meglio dove non è intervenuto l’architetto né qualche sagace amministratore” (A. Rossi, Autobiografia scientifica, Milano 1999, p. 107).
5 G. Leopardi, Zibaldone, ed. W. Binni, I, Firenze 1969, p. 484.
6 P. Eisenman, Interview Peter Eisenman + Lynn Breslin, “Space Design”, 3, 1986, p. 65.
7 W. Wenders, L’atto di vedere, Milano 1992, p. 90.
da Paolo Belardi, Il rilievo insolito. Irrilevabile, irrilevante, irrilevato, Quattroemme, 2001
"Uno dei più grossi lavori di quest’anno fu di scavare dall’alto in basso, a strati, una grossa massa di terra rimasta ancora intatta sul lato ovest e sud di Pergamo. Questo scavo aveva il massimo interesse per la scienza perché al centro dell’acropoli i Romani avevano distrutto le mura delle abitazioni dei più antichi strati superiori, per ottenere una piattaforma, mentre qui, fuori della Pergamo della seconda città, quella bruciata, e più vicino al muro dell’acropoli romana, le mura delle abitazioni sono conservate con le loro fondamenta per circa un metro di altezza in media. Esse presentano quattro insediamenti, che si sono susseguiti l’uno sull’altro dopo la rovina dell’ultima città preistorica, e ancora al di sotto, prima di raggiungere il terreno di base della seconda città, si trovano le mura delle abitazioni di altri tre insediamenti preistorici che si sono susseguiti l’uno sull’altro” (Heinrich Schliemann).
Quando guardiamo le architetture del passato, si tratti di una parte di città o anche più semplicemente di un singolo edificio, c’interessiamo prevalentemente della loro configurazione; nel senso che in genere è proprio la forma, e quindi l’immagine di un manufatto architettonico, al di là di qualsiasi ragione distributivo-strutturale, quella che percepiamo. Non solo. La forma che memorizziamo, almeno nei casi in cui le nostre attenzioni non comportano particolari intenzionalità analitiche, è per lo più quella attuale; come cioè la stessa si è venuta conformando, nel tempo, fino ai nostri giorni. Se ad esempio ci troviamo nella chiesa abbaziale di San Galgano, presso Siena, siamo colpiti dalla particolare condizione ipetrale e difficilmente ci poniamo il problema di ricostruire mentalmente la situazione spaziale originale. Ciò che al contrario ci emoziona è proprio l’eccezionalità della condizione diruta, con il pavimento erboso e i raggi solari filtranti attraverso le alte bifore della navata. Così come, nella loggia rinascimentale della basilica dei Santissimi Apostoli a Roma, il contrasto fra la dinamicità del primo ordine e il rigore dell’attacco a terra è determinato dalle alterazioni barocche dell’impianto originario, allorché, su disegno di Carlo Rainaldi, gli intercolunni del livello superiore vengono prima murati, quindi parzialmente sfondati con l’introduzione di ampie finestrature decorate e, infine, coronati con una balaustra di nuova invenzione. In entrambi i casi non interessa più di tanto il fatto che le due configurazioni formali sono state determinate da eventi assolutamente estranei alle intenzionalità progettuali originarie (lo smantellamento della copertura causato dalla negligenza dell’abate commendatario Girolamo Vitelli, nel caso dell’abbazia cistercense, e i lavori di ristrutturazione funzionale promossi dal cardinale Brancati di Lauria, nel caso della basilica romana): ciò che percepiamo e memorizziamo sono comunque le stratificazioni architettoniche finali sotto i nostri occhi (1). Stratificazioni architettoniche peraltro generate non solo da processi di costruzione, ma anche di decostruzione. Infatti, se la basilica dei Santissimi Apostoli si presenta come un sistema complesso di segni sovrapposti, che tradiscono lo sfogliamento progressivo della composizione originaria, la chiesa abbaziale di San Galgano trova forza espressiva proprio nella condizione di rudere (forse la più drammatica forma di decostruzione), in quanto l’unitarietà del manufatto architettonico di partenza è negato dalla decomposizione strutturale e, con essa, dal progressivo riassorbimento nel paesaggio naturale.
D’altra parte, consapevoli di come un’architettura stratificata comporti un grado di complessità e un’individualità non parimenti riscontrabile in un manufatto o comunque in una struttura urbana concepita unitariamente, avvertiamo, seppure inconsciamente, lo spessore dei pensieri sedimentati e siamo coinvolti proprio da quegli esempi in cui l’innovazione appare talmente debitrice alla situazione preesistente da risultare altrimenti gratuita; in un certo senso le stesse motivazioni che, in un passo de Il fauno di marmo di Nathaniel Hawthorne, spingono una comitiva di artisti anglo-americani, impegnati nella classica passeggiata romana al chiaro di luna, a deviare dal percorso diretto, dal Foro di Traiano al Colosseo, “per poter ammirare [...] il portico di un tempio dedicato a Minerva [...] all’interno del quale si è stabilito un macellaio, con l’ingresso aperto in un fianco” (2). Ansia di manierismo? Gusto del pittoresco? Forse, ma più ancora l’esigenza di marcare lo scarto fra collocazione e dislocazione, fra modello e invenzione; esigenza che, implicitamente, chiama in causa il concetto strutturalista di palinsesto e, con esso, quelle ambiguità architettoniche impreviste, in quanto non programmate nel progetto originario, che Robert Venturi definisce lucidamente “contraddizioni evidenziate” (3). Nel palazzo Tarugi di Montepulciano, ad esempio, la condizione d’angolo, involontariamente esaltata dall’occlusione funzionale del loggiato superiore, prevale sulla centralità dell’organismo concepito da Antonio da Sangallo il Vecchio? E ancora, nella basilica di San Venanzio a Camerino, il fuori scala è imputabile ai preziosismi del portale trecentesco o piuttosto all’ordine gigante del pronao neoclassico anteposto da Luigi Poletti nell’Ottocento? Mentre, all’opposto, proviamo una qualche estraneità rispetto ai manufatti architettonici rimasti immutati nel corso dei secoli: simulacri di una compiutezza che, in un certo senso, ci insospettisce e conferisce agli stessi un carattere più archeologico-museale che non schiettamente urbano. Basti pensare, ad esempio, alla ricostruzione del palazzo della Mercanzia di Bologna o, più ancora, all’integrità monotonale di interi centri storici cristallizzati nel tempo come Carcassonne e Toledo. Sappiamo bene, infatti, che una qualsiasi architettura, per assurgere a fatto urbano, deve necessariamente evolversi come struttura dialettica, assumendo un ruolo significante nell’ambito della geografia urbana non solo in virtù della mera permanenza topografica, ma anche e soprattutto a causa delle successive modificazioni indotte nel tempo. Avviene così che la concatenazione di esiti formali eterogenei, magari anche contraddittori, costituisce a buon diritto una categoria interpretativa autonoma, che di per sé prescinde qualsiasi catalogazione meramente stilistico-gerarchica e, di contro, propone un’ampia campionatura delle potenzialità integrative fra progetto e preesistenze. In questo senso l’oggetto del nostro interesse può essere rappresentato dal teatro Sanzio di Urbino (sovrapposto da Vincenzo Ghinelli nell’Ottocento al cinquecentesco torrione dell’Abbondanza di Francesco di Giorgio Martini) come dall’arena di Tarazona (edificata nel Settecento come plaza de toros e solo successivamente trasformato in quartiere popolare), dalla basilica di Santa Maria degli Angeli di Assisi (che ingloba la chiesetta della Porziuncola) come dal Partenone di Atene (a lungo convertito in moschea) (4). Consideriamo per un momento, in proposito, il caso emblematico del monastero di Santa Caterina, nel cuore Sinai: una struttura conventuale cresciuta intorno alla cappella fatta erigere nel IV secolo sul luogo del roveto ardente e che, nel tempo, ha assunto l’aspetto di una pittoresca cittadella fortificata in virtù di continue, quanto disinvolte, addizioni edilizie e, soprattutto, a seguito dell’erezione del recinto murario voluto dall’imperatore Giustiniano a protezione dalle scorrerie delle tribù nomadi. Considerata a sé, nessuna delle singole strutture architettoniche incorporate appare eccezionale, mentre è proprio la forte impressione trasmessa dall’insieme a giustificare la sensazione di trovarci di fronte a una microcittà: un vero e proprio palazzo-città che, pur in assenza di un disegno programmatico, presenta una straordinaria unitarietà compositiva, che in qualche modo incarna l’ideale estetico di Giacomo Leopardi quando, nello Zibaldone, sostiene che “al piacere contribuisce la varietà, l’incertezza, il non vedere tutto e il potersi perciò spaziare con l’immaginazione riguardo a ciò che non si vede […] – perché - il piacere dell’incertezza e della varietà prevale a quello dell’apparente infinità, e dell’immensa uniformità” (5). In questo senso la varietà, l’incertezza, il non vedere subito tutto, diventano la possibilità di accedere con l’immaginazione a ciò che non è visibile, riconoscendo una qualità intrinseca alle complicazioni indotte dai processi di modificazione.
Ma c’è dell’altro. Infatti è solo percorrendo le vie di uno qualsiasi dei centri storici europei che, grazie alla percezione del ritmo incalzante generato dalle irregolarità impreviste oltre che dai repentini cambiamenti di scala, riusciamo a convincerci di come tali eventi possono essere prodotti sempre e soltanto da quel lavoro collettivo cui Eisenman riconosce la capacità di conferire il crisma della intrasferibilità: Two pieces: the quarry and the palimpsest ... Now you take the stones and build one project. Someone else will take the stones from your project and buid something else ... We start from the palimpsest which is the superposition of two pieces which then becomes a quarry and then you subtract from the palimsest leaving the trace of the former superposition, but also the trace of the subtraction, so in other words we are talking about “chora”. The combination of the superposition of palimpsest and quarry gives you “chora” (6). In effetti, se un modello tipologico, in quanto coerente e unitario, può essere ragionevolmente riproposto anche in contesti diversi, non potremo mai trasferire integralmente, a meno di artificiose forzature, la climax pittoresca del rione San Pellegrino di Viterbo o le sovradiacenze del palazzo del Popolo di Ascoli Piceno, perché intimamente connesse e strutturate, nei processi combinatori dei diversi addendi, alle peculiarità dell’hic et nunc; così come nello sfondo del San Sebastiano di Andrea Mantegna, dove alcuni edifici classici in disfacimento, insieme a un acquedotto romano con i fornici utilizzati a botteghe e a un arco trionfale sopraelevato, disegnano uno spaccato architettonico in cui l’astratto rigore geometrico rinascimentale attinge forza espressiva proprio dalle complicazioni di una città costruita e decostruita pezzo per pezzo dal fattore T (tempo). Così, seppure non conferiremo mai sufficiente importanza alla complessità degli esiti finali e nonostante la città tenda a eludere i perimetri angusti di qualsiasi sovrastruttura critica artificiosamente imposta, appare comunque conveniente rilevare, organizzandola razionalmente, la sistematicità di processi formativi la cui oggettiva necessità è testimoniata proprio dalla ricorrenza in ambiti e culture profondamente lontane, sia temporalmente che geograficamente. Esemplificativa in proposito la celebre Veduta ideale di piazza italiana di Karl Friedrich Shinkel, un curioso montaggio eclettico in cui il sommo architetto prussiano, frantumando le barriere spazio-temporali, accosta con disinvoltura memorie archeologiche romane e pavimentazioni rinascimentali, le Procuratie e i dioscuri del Quirinale. Il risultato è uno scorcio urbano evidentemente immaginario, almeno nei suoi esiti formali, che tuttavia potrebbe sussistere realmente qualora, in qualche luogo, si fossero presentate le condizioni per il concretarsi di una tale contaminazione architettonica.
Nondimeno, dall’analisi di un qualsiasi fatto urbano, appare enucleabile, all’interno delle diverse sedimentazioni, una prima grande distinzione fra quelle modificazioni architettoniche che non comportano sensibili variazioni nell’inviluppo volumetrico delle preesistenze (Stratificazioni senza variazione di sagoma) e, all’opposto, quelle modificazioni architettoniche che comportano sostanziali alterazioni dello stesso (Stratificazioni con variazione di sagoma).
Risultando le Stratificazioni senza variazione di sagoma articolate in processi di:
- Metamorfosi (trasformazione interna da una organizzazione spaziale ad un’altra) ;
- Inglobamento/Inclusione (incorporazione di uno o più manufatti preesistenti o inserimento, all’interno di un corpo edilizio, di uno o più manufatti indipendenti);
- Trasferimento (scomposizione e ricostruzione, in nuovi contesti, di un intero manufatto architettonico).
Mentre all’interno delle Stratificazioni con variazione di sagoma appaiono enucleabili processi di:
- Addizione (accumulazione di interi corpi edilizi o di nuovi elementi architettonici intorno ad un nucleo originario);
- Sottrazione (rimozione, deliberata e non, di parti di un manufatto architettonico);
- Sovrapposizione (edificazione, superiormente al manufatto originario, di nuovi corpi edilizi).
Considerando poi che, come facilmente riscontrabile, la maggior parte delle architetture stratificate è riconducibile a combinazioni di volta in volta diverse, sia qualitativamente che quantitativamente, delle categorie dinamiche elementari sopra elencate, se non addirittura di tutte simultaneamente. Basti pensare ai casi emblematici del palazzo di Diocleziano a Spalato, dell’anfitetro di Nimes e della Rocca Paolina a Perugia. Laddove, nei primi due esempi, il palazzo imperiale e l’anfiteatro romano si trasformano spontaneamente in altrettanti nuclei cittadini; mentre, nel terzo, l’antico quartiere dei Baglioni viene convertito in fortezza papale da Antonio da Sangallo il Giovane che, con spirito antiquario, preserva parte del tessuto edilizio del colle Landone come sostruzione. Episodi architettonici, questi, così complessi e intricati da renderci pienamente coscienti del surplus estetico delle stratificazioni architettoniche; perché, da sempre, “le ferite di una città raccontano la sua storia meglio di qualsiasi libro o documento” (7).
Note
1 ”Esiste un altro luogo concettuale fondamentale [...] si tratta dell’idea di stratificazione. Se io osservo un disegno che mi restituisce la sovrapposizione di diverse giaciture di resti, ad esempio una planimetria del Foro Romano con in rosso le murature repubblicane, in giallo quelle del primo impero e in blu le tracce delle edificazioni del terzo secolo dopo Cristo, mi confronto con un’immagine che "visivamente" si presenta come un sistema di segni che si scompone nelle sue parti quasi per un percepibile movimento. Attraverso una sorta di accelerazione mentale posso letteralmente assistere allo "sfogliamento" progressivo di questo testo edilizio” (F. Purini, La forma storica della decostruzione nella architettura italiana, in B. Bottero (a cura di), Decostruzione in architettura e filosofia, Milano 1991, p. 53).
2 N. Hawthorne, Il fauno di marmo, Roma 1945, pp. 63-64.
3 R. Venturi, Complessità e contraddizioni nell’architettura, Bari 1980, pp. 69-84.
4 “É evidente che ogni cosa ha una sua funzione a cui deve rispondere ma la cosa non finisce lì perché le funzioni variano nel tempo. É stata sempre questa una mia affermazione di carattere scientifico che ho tratto dalla storia della città e dalla storia della vita dell’uomo: la trasformazione di un palazzo, di un anfiteatro, di un convento, di una casa e dei loro diversi contesti. Mi sono sempre riferito a questo parlando dei monumenti perché ho visto palazzi antichi abitati da molte famiglie, conventi trasformati in scuole, anfiteatri trasformati in campi da pallone e questo è sempre avvenuto meglio dove non è intervenuto l’architetto né qualche sagace amministratore” (A. Rossi, Autobiografia scientifica, Milano 1999, p. 107).
5 G. Leopardi, Zibaldone, ed. W. Binni, I, Firenze 1969, p. 484.
6 P. Eisenman, Interview Peter Eisenman + Lynn Breslin, “Space Design”, 3, 1986, p. 65.
7 W. Wenders, L’atto di vedere, Milano 1992, p. 90.
Sotto/Sopra
Il fascino del vivere ipogeo
da Paolo Belardi, Il rilievo insolito. Irrilevabile, irrilevante, irrilevato, Quattroemme, 2001
da Paolo Belardi, Il rilievo insolito. Irrilevabile, irrilevante, irrilevato, Quattroemme, 2001
C’è un curioso schizzo di Hans Hollein, dove la mitica nave transoceanica di Le Corbusier è ritratta nell’atto di sprofondare nel sottosuolo, che, al di là dell’evidente ironia, segna una svolta epocale, perché sancisce il definitivo fallimento delle megastrutture urbane (a cominciare proprio dalla ville radieuse) e ristabilisce il tradizionale connubio utopia-ipogeismo; un connubio peraltro profetizzato da Antonio Sant’Elia nel Manifesto dell’Architettura Futurista del 1914 (“la strada [...] si sprofonderà nella terra per parecchi piani - perché occorre - utilizzare i sotterranei” (1)), ma sostanzialmente misconosciuto dal modernismo, che all’opposto, insorgendo contro la drammatica precarietà delle abitazioni protoindustriali (allorché la classe operaia è confinata in malsani locali sotterranei), enfatizza la necessità biologica della luce e associa tout court connotazioni negative all’assenza della stessa. Esemplificative, in proposito, le scenografie del film Metropolis di Fritz Lang in cui il contrappunto fra i padroni e gli operai è rimarcato proprio dalle opposte ambientazioni: luminosi giardini pensili per i primi e lugubri sotterrani per i secondi.
Eppure, a ben guardare, lo spazio della caverna (di volta in volta giaciglio primordiale, rifugio, ma anche ritiro ascetico (2)) eccita da sempre l’immaginario collettivo, sollevando al contempo attrazioni ancestrali (l’alveo materno) e misteriose inquietudini (l’angoscia del sepolcro); secondo un intrigante rapporto di orrore-piacere che informa tutta la cultura classica (nessuno degli eroi epici si sottrae al cimento della discesa agli inferi) e investe conflittualmente la stessa religione cristiana. Laddove la caverna, nel tentativo di scongiurare qualsiasi rigurgito misterico-pagano, viene rappresentata iconograficamente come sede di oscure forze malefiche (nell’età medievale le immagini della spelonca e del dragone sono pressoché indissolubili), per quanto poi, paradossalmente, il cammino del cristianesimo incrocia continuamente quello dell’ipogeismo: dalla catacombe alle cripte, dai santuari rupestri alle dimore anacoretiche. Né d’altra parte il Novecento è esente da declinazioni ipogee. Il mito della montagna cosmica, infatti, ispira gran parte dell’architettura espressionista, contrassegnata da “visioni di città che, per Hermann Finsterlin, si plasmano in mareggiate di pietra continuamente percorribili nel loro involucro esterno e interno; per Carl Krayl, in selve di guglie dolomitiche; mentre altri architetti, quali Hans Sharoun e Poelzig, progettano interni di templi e teatri simili a pungenti o fiammeggianti caverne stalattitiche” (3); prefigurazioni immaginifiche, quelle espressioniste, che, unitamente all’Alpinearchitektur di Bruno Taut (in cui “intere montagne vengono trasformate, scavate o “completate” da segni cosmologici” (4)), preludono alla costituzione, nel 1933, del Groupe d’Etudes et Coordination de l’Urbanisme Souterrain, un’organizzazione ideata da Edouard Utudjian e finalizzata alla sensibilizzazione del grande pubblico per le virtualità ecologiche di un’auspicata ville en épaisseur. Ma l’impegno messianico dell’allievo di Perret trova scarsi proseliti. Infatti, nonostante l’episodicità delle architetture semitroglodite di Frank Lloyd Wright (che sprofonda nel suolo vegetale parti della Jacobs House e delle Cooperative Homesteads) e di Philip Johnson (Geier House), è solo nel cuore degli anni sessanta che le tendenze radicali riscoprono le valenze utopiche dell’habitat sotterraneo: dalle avveniristiche proposte di Paul Maymont per Parigi (una megalopoli lineare ricavata inferiormente all’alveo della Senna) alla Ville Cratère di Louis Chanéac (articolata in un sistema di cavità artificiali interconnesse), dalla Subartic City di Ralph Erskine agli insediamenti neoanasazi di Paolo Soleri (scavati nella roccia e climatizzati mediante lo sfruttamento dell’energia eolico-solare): Arcoindian, Infrababel, Theology ecc. Non a caso l’impasse psicologico-culturale nei confronti dell’abitare ipogeo è superato contestualmente diffusione della propensione hippie per “il vivere armonioso nella natura”e, ancorpiù, a seguito della crisi energetica indotta dall’embargo petrolifero nei primi anni settanta. Sono, infatti, le esigenze di salvaguardia ambientale (la coscienza del territorio come bene limitato, la lotta agli agenti inquinanti ecc.) unitamente alle rinnovate tecniche di controllo ambientale (5) (le stesse in cui confidavano Boccioni e Sant’Elia) ad ampliare le prospettive di un sottosuolo non più interpretabile riduttivamente quale mero spazio rituale-cultuale, quanto piuttosto come preziosa protesi dell’esistente. Così, parallelamente alla proliferazione di architetture sempre più trasparenti e rarefatte, l’architettura dell’ultimo scorcio del XX secolo annovera comunque imprese ipogee (6) nel cui elenco risaltano la concretezza di Gunnar Birkerts e la poeticità di Emilio Ambasz. Birkerts, infatti, recuperando il senso più profondo della lezione impartita da William Morgan sia da un punto di vista teorico (redigendo una meticolosa catalogazione tipologica (7) articolata in shaped hills, mounds, retained earth, shafts, terraces, tunnels e caves) che da un punto di vista applicativo (costruendo numerose abitazioni ipogee: Dune House, Forest House, Hilltop House ecc.), si “è guadagnato – sul campo - la fama di esperto in espansioni sotterranee” (8). Soprattutto con l’ampliamento della Law Library di Ann Arbor, realizzata nel campus dell’University of Michigan ed esemplare proprio perché “elaborata nel rispetto dell’edificio originario” (9): occasione in cui Birkerts, dopo avere a lungo indugiato su ipotesi superficiali, opta per una soluzione completamente ipogea, occupando il sottosuolo dell’esigua area disponibile e ritagliando, in corrispondenza dell’edificio neogotico preesistente, un’asola vetrata capace di garantire, in virtù di un sofisticato sistema di pareti specchianti, l’afflusso della luce naturale all’interno della biblioteca nonché l’integrazione percettiva tra interno ed esterno. Mentre Ambasz, nel Botanical Center di San Antonio, rimodella il terreno collinare e ricava mimeticamente, al di sotto dei diversi tumuli artificiali, altrettante serre botaniche, caratterizzata da condizioni climatiche autonome e denunciate visivamente da misteriose cuspidi vetrate which give the roofs a hieratic presence as an arrangement of secular temples sitting serenely in the landscape (10).
Tuttavia, nonostante il successo delle fascinose architetture di Birkerts e di Ambasz, l’ipogeismo continua a rappresentare una sorta di nicchia disciplinare, frequentata manieristicamente piuttosto che indagata criticamente. Peraltro, se nel resto dell’Europa la sensibilità ambientalista impone talora di per sé l’adozione di soluzioni interrate (dal museo dell’orologio a La Chaux-de-Fonds di Pierre Zolley alla stazione radio di Gustav Peichl ad Aflenz fino al centro termale di Otto Glaus a Baden Baden), in Italia sono gli stessi ordinamenti legislativi (segnatamente le norme igienico-sanitarie, per lo più inadeguate alle potenzialità del progresso tecnologico) a scoraggiare qualsiasi forma di ipogeismo, limitando la realizzazione di locali interrati a ragioni di mera convenienza volumetrica e, quindi, associando idealmente ipogeismo e abusivismo; tanto da avvalorare il convincimento comune che tende a interpretare le abitazioni interrate come ripiego. E di ripiego certo si tratta, se si considerano gli scantinati, per lo più insalubri, dei nostri centri storici (mai concepiti a fini propriamente abitativi), ma non se si pensa alle qualità ambientali dei Sassi di Matera (una volta eliminate le cause prime del disagio: sovraffollamento, promiscuità con il bestiame e carenza di servizi) o, più ancora, alle rare realizzazioni ipogee sfuggite alla censura normativa, quali ad esempio i progetti di Roberto Gabetti e Aimaro Isola per Sestrière, Volterraio all’Isola d’Elba e, soprattutto, Ivrea: un crescent residenziale incassato nel terreno (11) che, con la propria innovatività tipologica, costituisce la prova tangibile di come, manipolando la crosta terrestre e controllando opportunamente il progetto in sezione (vero e proprio luogo ideativo), si possono concepire residenze non solo perfettamente funzionali, ma anche e soprattutto piacevoli, contrapponendo modelli inediti alla rigida anomia degli epigoni tardo-razionalisti e riscoprendo valori precipui dell’abitare (l’intimità, la singolarità, il senso di protezione) troppo a lungo sacrificati in nome di una presunta, quanto distorta, idea della modernità.
Note
1 A. Sant’Elia, L’Architettura futurista. Manifesto dell’11 luglio 1914, in R. Gabetti (a cura di), La nuova architettura e i suoi ambienti, Torino 1985, p. 39.
2 P. Supik, Forme dell’architettura trogloditica, in G. Cataldi (a cura di), Le ragioni dell’abitare, Firenze 1988, pp. 234-248.
3 M. Nicoletti, L’architettura delle caverne, Roma-Bari 1980, p. 20.
4 M. Nicoletti, op. cit., p. 20.
5 “La città sotterranea evoca a tutta prima immagini cupe; fa pensare alle necropoli; alle coketowns, ai rifugi atomici. Evoca thanatos piuttosto che eros. Nel secolo di Orwell, la città ipogea fa pensare a un formicaio automatizzato in cui gli uomini vivono la loro ‘notte cosmica’. Lewis Munford nella Città nella Storia (The City in History) scrisse parole di critica tagliente: ‘La città sotterranea esige la sorveglianza continua di uomini vivi, costretti anch’essi a starsene sottoterra; e questa imposizione è poco meno che una inumazione prematura o, nella migliore delle ipotesi, prelude a quell’esistenza incapsulata che sarà la sola aperta a coloro che considerano il progresso meccanico la principale giustificazione dell’avventura umana’. Il tono apocalittico di Munford, in certa misura legittimo, non teneva in troppo conto il potere dei media elettronici che frantumando le barriere dello spazio e del tempo consentono di gestire dall’esterno un’automazione quasi totale, anche sotterranea” (M. Cecchetti, L’habitat ipogeo, “L’Arca”, 10, 1987, p. 1).
6 Cfr. in proposito E. Burger, Geomorphic Architecture, New York 1986.
7 W. Morgan, The earth. Discussing the basic issues, “Progressive Architecture”, 4, 1967, pp. 176-184.
8 K. Kaiser, G. Birkerts. Metafore ed espansioni sotterranee, Torino 1998, p. 60.
9 K. Kaiser, op. cit., p. 60.
10 E. Ambasz, Emilio Ambasz. The poetics of the pragmatic, New York 1988, p. 54.
11 “La Residenziale Ovest per l’Olivetti ad Ivrea può prestarsi ad una lettura in questa chiave: la “mimesi” anziché omologare l’esistente e cancellare il nuovo, ciò che c’era, fa un segno, cioè indica, pone in evidenza ciò che c’era, cerca di dare un senso ad un paesaggio, facendolo esistere, abitare. In questo semicerchio c’è forse, anche se non intenzionale, un’allusione alla “cavea”, ad un teatro costruito attorno ad un paesaggio che si fa attore e che muta nel tempo; la terra, il prato, gli alberi, se da una parte occultano il costruito nel paesaggio, facendolo appartenere alla “natura”, sono, contemporaneamente, promossi a materiale da costruzione, diventano Ordine, architettura, diventano spazio dell’abitare” (R. Gabetti, A. Oreglia D’Isola, Per i nuovi valori dell’ambiente, in F. Rossi Prodi (a cura di), Costruire-Decostruire, Roma 1992, pp. 174-175).
Nulla dies sine linea
Una lezione sul disegno inventivoda Paolo Belardi, Nulla dies sine linea. Una lezione sul disegno inventivo, Libria, 2012
Racconta Giorgio Vasari nella Vita di Paolo Uccello che quest’ultimo era solito trattenersi fino a notte fonda nello scrittoio “per trovare i termini della prospettiva”. E che, quando la moglie lo invitava a coricarsi con lei, lui continuava imperterrito a disegnare, sospirando estasiato: “oh che dolce cosa è questa prospettiva!”. Al di là della sua veridicità, l’aneddoto è ormai entrato nella storia, anche grazie alla validazione vasariana, laddove conclude la biografia sentenziando che è proprio grazie alle notti insonni di Paolo Uccello che l’arte prospettica fu “cara ed utile a coloro che in quella si sono dopo di lui esercitati”: da Piero della Francesca a Leonardo da Vinci. Serrando lo studio del disegno con l’insegnamento del disegno nell’egida dell’amore per il disegno. E, forse, è proprio per rimarcare la necessità (oltre che l’attualità) di questo legame indissolubile che, dopo trent’anni di attività didattica e di ricerca, mi sono cimentato nel fissare una “rete fiduciaria” per il nuovo millennio, dichiarando apertamente (ma senza presunzione di esaustività) il mio punto di vista sul futuro del disegno. Ho così messo a punto il canovaccio di due prolusioni virtuali (che in realtà non ho mai tenuto, ma che ho riferito a corsi universitari che ho tenuto realmente), volte a lumeggiare le ragioni per cui gli architetti continuano a disegnare, in cui ho riversato tutta la mia passione e ho condensato tutto il mio sapere: la prima rivolta agli studenti di un ipotetico corso di “Disegno automatico”, in cui mi sono interrogato sui destini del disegno manuale di fronte all’irruzione dei media elettronici (rivendicando il ruolo decisivo dello schizzo come interfaccia tra pensiero e opera nella fase aurorale del progetto); la seconda rivolta agli studenti di un altrettanto ipotetico corso di “Rilievo dell’architettura”, in cui mi sono interrogato sul significato della misura nell’era del laser scanner e del global positioning system (rimarcando la sterilità delle tecniche che privilegiano l’esattezza metrica rispetto all’appropriatezza culturale). In verità non so se i riferimenti addotti nelle due lezioni sono pertinenti e tanto meno so se l’organizzazione retorica prescelta è ortodossa. Ma so per certo che la tesi sostenuta (che in fondo è sempre la stessa) non è velleitaria, perché molti segnali fanno supporre che, anche nell’era digitale, il disegno conserverà intatto il proprio ruolo di pietra angolare dell’architettura, assurgendo ancorpiù a forma privilegiata di pensiero tanto nell’atto ideativo quanto nell’atto conoscitivo. Così come attestano gli schizzi preparatori di Aldo Rossi, al cui cospetto neppure un altro grande disegnatore come Paolo Portoghesi riuscì a nascondere la propria ammirazione, declamando i versi di Libero de Liberi: “dal nulla che ero, mi facesti dono d’essere uno che ti guardava”. Non a caso, seppure il testo delle due prolusioni è punteggiato da continue citazioni testuali ed è chiosato da ripetute allusioni iconografiche, la veste editoriale prescelta, emulando il tono evocativo dei vecchi romanzi d’appendice (che demandavano gli approfondimenti e la visualizzazione dei personaggi alla fantasia del lettore), è priva di note e, soprattutto, di illustrazioni. Proprio perché mi stanno a cuore le sorti del disegno-pensiero, sono sempre più nauseato dall’horror pleni di saggi in cui la marginalità dei commenti distoglie dalla centralità della proposizione e di messaggi pubblicitari che molto dicono e poco (o nulla) comunicano. Mentre sono sempre più sensibile alla severa rampogna di William Wordsworth: “Basta, col vile abuso delle pagine dipinte! L’occhio sarà ormai tutto, e lingua e orecchio nulla?”
Laboratorio Italia
Intervista a Paolo BelardiLaboratorio Italia , in “d’Architettura”, 38 (2009), pp. 16-17
Laboratorio Italia – Gli architetti italiani sulla sostenibilità, “Archinfo”, http://www.archinfo.it/gli-architetti-italiani-sulla-sostenibilita/0,1254,53_ART_305,00.html [17.04.2014]
Cosa intendi per “sostenibilità” in relazione al progetto di architettura?
Forse perché sono umbro, e quindi sono particolarmente sensibile al pensiero francescano, per sostenibilità intendo il rispetto e la cura della terra. Il che, se relazionato al progetto di architettura, significa evitare di sprecare inutilmente le risorse ambientali e governare virtuosamente le modificazioni degli agenti fisici e biologici. Ovvero significa concepire ogni intervento non come fine a se stesso, ma come parte di un insieme. Il concetto di sostenibilità è quindi legato indissolubilmente ai concetti di fratellanza e di appartenenza. Così come puntualizzato fin dai primi anni Cinquanta dal Richard Neutra di Survival Through Design/Progettare per sopravvivere.
Ritieni che la sostenibilità sia o possa divenire, in sé, un tema di architettura?
La sostenibilità, parafrasando un’acuta notazione di Massimo Pica Ciamarra, sostiene da sempre l’architettura. Ma ormai l’architettura sostenibile è diventata una polirematica modaiola onnicomprensiva e, quindi, assolutamente generica: un grimaldello professionale volto a strappare il “permesso a costruire” (al pari del servizio igienico 1,80 per 1,80 metri nel caso dell’accessibilità) o, più ancora, un vessillo ideologico sbandierato senza cuore anche da coloro che contrabbandano per sostenibili interventi edilizi manifestamente insostenibili. Così come appalesato dagli “orrendering” pubblicati a corredo della gran parte degli annunci immobiliari.
Quale relazione esiste, nella tua ricerca, tra il problema della sostenibilità e le scelte di linguaggio architettonico?
Da ingegnere che lavora con altri ingegneri e insegna in una facoltà d’ingegneria (ma che ama l’architettura nel senso indicato da Giò Ponti), sono consapevole del fatto che, per rendere sostenibile un edificio, non basta infarcirne il tetto con pannelli fotovoltaici o con pale microeoliche. Un edificio sostenibile non è la sommatoria degli eco-gadgets presentati nell’ultima manifestazione fieristica, ma è l’integrale alla data dei saperi umanistici e scientifici della comunità cui appartiene. Ovvero è una vera e propria condizione culturale.
Ritieni che vi siano materie o tecniche costruttive specifiche in relazione al problema della sostenibilità?
Si, anche se insolite quanto forse desuete: l’etica, l’estetica e l’euristica. Anche in materia di architettura sostenibile, infatti, il senso della morale, l’amore per la bellezza e il coraggio delle idee (in sintesi la cultura del progetto) rappresentano componenti progettuali ben più efficaci e incisive delle vernici antipolveri o delle pareti ventilate. In tal senso, quella della sostenibilità è una grande sfida creativa che, imponendo un sensibile rinnovamento tipologico, potrebbe aprire nuovi scenari disciplinari. Magari restituendo alla nostra categoria professionale la credibilità necessaria per ricucire lo strappo tra addetti ai lavori e grande pubblico.
Potresti commentare la frase di Alvaro Siza “La tradizione è una sfida all’innovazione”?
Dal punto di vista della sostenibilità, non ha senso approfondire l’aspetto energetico trascurando l’aspetto compositivo. Perché una casa molto efficiente dal punto di vista energetico, ma brutta, è meno sostenibile di una casa poco efficiente dal punto di vista energetico, ma bella. Almeno fino a quando la qualità del paesaggio rimarrà un valore da tutelare. Così come non ha senso coltivare la cultura della separatezza disciplinare. Altrimenti rischiamo di disseminare edifici più o meno intelligenti all’interno di una città stupida. Questo i nostri avi lo sapevano benissimo. Basta pensare a come sia le case rurali che le ville patrizie (e con esse le città storiche in genere), oltre a essere bellissime, funzionavano (e spesso funzionano tuttora) perfettamente dal punto di vista bioclimatico grazie ai semplici principi metaprogettuali (orientamento, esposizione, forma ecc.) su cui era fondata l’architettura della città.
Why Architects Still Draw
da Paolo Belardi, WHY ARCHITECTS STILL DRAW, The MIT Press, Cambridge (USA), 2014
In his “Life of Paolo Uccello,” written in 1550, Giorgio Vasari tells us that the artist would stay in his study until late at night “seeking to solve the problems of perspective.” Even when his wife would call him to come to bed, he would continue to draw, whispering in ecstasy, “Oh, what a sweet thing is this perspective!” Whether it is actually true or not, this anecdote has taken its place in the annals of history because of Vasari’s approval of the Uccello’s late-night practice: he ends his biography of Uccello saying that it was thanks to the artist’s sleepless nights that the art of prospective was “dear and useful to those who exercised themselves therein after his time,” from Piero della Francesca to Leonardo da Vinci, thus permanently linking the study and practice of drawing with the idea of devotion. Perhaps it’s precisely to demonstrate this connection that, after thirty years of teaching and research, I am now developing a network of trusted collaborators with whom to share and exchange views on the future of drawing, though without the presumption of having the last word.
In his “Life of Paolo Uccello,” written in 1550, Giorgio Vasari tells us that the artist would stay in his study until late at night “seeking to solve the problems of perspective.” Even when his wife would call him to come to bed, he would continue to draw, whispering in ecstasy, “Oh, what a sweet thing is this perspective!” Whether it is actually true or not, this anecdote has taken its place in the annals of history because of Vasari’s approval of the Uccello’s late-night practice: he ends his biography of Uccello saying that it was thanks to the artist’s sleepless nights that the art of prospective was “dear and useful to those who exercised themselves therein after his time,” from Piero della Francesca to Leonardo da Vinci, thus permanently linking the study and practice of drawing with the idea of devotion. Perhaps it’s precisely to demonstrate this connection that, after thirty years of teaching and research, I am now developing a network of trusted collaborators with whom to share and exchange views on the future of drawing, though without the presumption of having the last word.
With my colleagues and students in mind, I’ve written two imaginary lectures which in reality I’ve never delivered (though they draw on courses I have taught at the University of Perugia). In these two lectures, I try to explain the reasons why architects still draw. Why do architects still draw? This book is a sort of didactic canvas on which I’ve spread both my passion and knowledge to try to answer this question in a meaningful way. The first lecture is for students of a course called “Automatic Drawing,” and it poses questions about the fate of drawing by hand in the age of electronic media, and especially about the role of sketching as an interface between thought and work in the initial phase of a project. The second lecture is for students in another made-up course, “Architectural Survey.” There I’ve explored the meaning of measurement in the era of the 3D scanner and the GPS device, trying to show the sterility of techniques that privilege metric exactitude over cultural appropriateness.
I don’t know whether the references I’ve used here are pertinent or if the rhetorical organization is orthodox. I do know, however, that my aim in both lectures is not in vain: that, even in the digital age, drawing will maintain its role as a cornerstone of architecture, reaching an even more privileged position as a way of thinking in both the creative and the informed act.
It is not by chance that this text—while peppered with quotes and iconographic allusions—doesn’t have footnotes or, more importantly, images. This editorial strategy was chosen deliberately to emulate the evocative tone of those old cliffhangers that relied on the reader’s imagination to conjure up vivid pictures of the characters and to embellish the narratives. I care about the fate of drawing-as-thought, and I’m disturbed by writing in which the futility of expression drives readers to immediately seek solace in something besides the text. As time passes, and I see more and more writing of this kind, I am reminded of William Wordsworth’s admonition:
Avaunt this vile abuse of pictured page!
Must eyes be all in all, the tongue and ear
Nothing? Heaven keep us from a lower stage
Kultur-Fabrik-Perugia
Da città-museo a museo-città
di Paolo Belardi
in L. Ferrucci (a cura di), I centri storici delle città tra ricerca di nuove identità e valorizzazione del commercio. L'esperienza di Perugia, FrancoAngeli, 2013
It is your town: know how to protect it
Intorno alla metà degli anni settanta il Consiglio d’Europa pubblicò un insolito saggio a carattere divulgativo, titolato It is your town: know how to protect it(Friedman, 1975) firmato dall’urbanista Yona Friedman, in cui l’elencazione dei problemi patiti dal centro storico di Whateborough (un'immaginaria città-campione sviluppatasi per successive stratificazioni e integrazioni del nucleo primitivo centrale) era suggellata da un interrogativo programmaticamente retorico (Who wants to live in a museum?) che, nel rivendicare il diritto all’accessibilità anche per le parti più intricate e impervie delle nostre città, non ammetteva incertezze sull’esattezza della risposta: Nobody! Né, all’epoca, avrebbe potuto essere diversamente, perché, dopo la promulgazione nel 1964 della Carta internazionale sulla conservazione ed il restauro dei monumenti e dei siti(Petroncelli, 2005, pp. 162-164), la museificazione ha rappresentato un vero e proprio incubo disciplinare, con cui tutte le iniziative intraprese in materia di recupero dei centri storici hanno dovuto fare i conti, finendo con l’avvitarsi inevitabilmente (e ineffettualmente) intorno a un asse problematico avverso alla cartolinizzazione del patrimonio storico-artistico. Ma le cose cambiano e, con esse, cambia necessariamente anche il nostro punto di vista. Oggi infatti, posti di fronte allo stesso interrogativo, esiteremmo a rispondere di getto e nutriremmo molti dubbi, magari ripensando alla laconica rampogna di Aldo Rossi, secondo cui il problema non è mai stato quello di scongiurare il rischio della città-museo, ma è sempre stato quello di governare l’opportunità del museo-città (Rossi, 1975).D’altronde, visti gli esiti fallimentari delle crociate contro l’ipetrofizzazione dei centri storici in reperto iconico dato in pasto ai turisti e considerato che il nostro paese (nonostante la sua dimensione limitata: 60 milioni di abitanti distribuiti su appena 300 mila chilometri quadrati) ospita il 40 per cento circa del patrimonio di opere artistiche e architettoniche del pianeta (L’Italia che verrà. Industria culturale, made in Italy e territorio, 2012), perché non provare a superare l’asfittica diatriba conservazione/innovazione e scommettere su un’ipotesi conciliativa, che ci consenta di partecipare attivamente, e non assistere passivamente, alla trasformazione dei nostri centri storici in altrettante fabbriche della cultura? Ovvero, posto che la cultura non è solo passato, ma è anche presente, progresso e sostenibilità, perché non provare a governare virtuosamente il processo di museificazione dei nostri centri storici (per certi versi inarrestabile) contrastando la deriva verso l’imbalsamazione formale e favorendo la convergenza verso la valorizzazione funzionale? In fondo, nell’era della cultura di massa, i musei non sono più né strutture obsolete né luoghi statici, ma sono sempre più strutture evolute e luoghi dinamici: veri e propri contenitori di saperi relazionali che, a ben guardare, sono l’unica componente urbana capace di appropriarsi della logica onnivora della città (Zuliani, 2006; Cataldo, Paraventi, 2007; Polveroni 2007; Bollo, 2008). Sfatando con l’occasione pregiudizi tra i più anacronistici: sia perché sono proprio i paesi che presentano i più alti livelli di partecipazione alle attività culturali a manifestare la maggiore capacità innovativa sia perché l’attrattività residenziale non solo non è penalizzata, ma è addirittura incentivata dall’attivazione di polarità museali (I musei italiani e i distretti culturali: punti di forza e di debolezza, 2012), Così come dimostrano i casi esemplari del Guggenheim Museum a Bilbao, della Museumsinsel a Berlino, del Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée a Marsiglia e del Museo nazionale delle Arti del XXI secolo a Roma.
La sostenibilità è made in Umbria
A differenza della città contemporanea, che ha divaricato a dismisura i propri confini, traslando i propri riferimenti dalla scala edilizia alla scala territoriale, la città storica, proprio perché cresciuta intrusivamente, è contrassegnata da un tessuto compatto, serrato all’interno delle mura urbiche, le cui dimensioni hanno sempre reso labili i limiti tra la scala edilizia e la scala urbana. E, anche in tal senso, il centro storico di Perugia non fa certo eccezione, proprio perché non presenta un disegno urbano caratterizzante, ma tradisce sempre e comunque geometrie interrotte, mai definitive. Non a caso la sua acropoli ha introiettato con pazienza lo schema ippodameo ereditato dal nucleo etrusco-romano, ha rigettato con veemenza la rocca sangallesca sovrapposta da Paolo III alle vestigia del quartiere dei Baglioni e ha accolto con tolleranza i palazzi cubisti calati in età postunitaria (Zevi, 1971; Grohmann, 1981). Fino ad inverare un processo costitutivo atipico, capace di superare tanto l’astrattezza del piano-programma quanto la concretezza dell’edificio-oggetto. Il che è convalidato da Bernard Rudofsky quando, celebrando la vocazione pedonale della Peroscia medievale, riconosce nelle case pensili di via dell’Acquedotto gli enzimi di un paesaggio urbano unico al mondo (Rudofsky, 1969), la cui condizione interrotta non è un dato fortuito, ma incarna l’esito di stratificazioni millenarie e, soprattutto, è la prova tangibile che l’idea di sostenibilità è profondamente made in Umbria, in quanto è parte integrante del DNA delle nostre città storiche. Anche se non ne abbiamo la piena consapevolezza. Forse perché, sfogliando le riviste di architettura, sembra quasi che la leggerezza, l’immaterialità e la trasparenza riassumano in sé il concetto di sostenibilità. E che un edificio tappezzato con vetrate scintillanti e farcito con pannelli fotovoltaici sia necessariamente più sostenibile di un edificio rivestito in pietra da taglio e orientato correttamente. Niente di più falso. Se è vero, infatti, che progettare in modo sostenibile significa prima di tutto evitare di sprecare inutilmente le risorse ambientali e governare virtuosamente il riciclo dei rifiuti, non dovrebbe essere difficile convincersi del fatto che i complessi più sostenibili della storia dell’architettura sono proprio i nostri centri storici: che sono cresciuti su se stessi, minimizzando il consumo del suolo, e dove ogni singola pietra, ogni singolo mattone, ogni singolo capitello non è stato smaltito in una qualche discarica di periferia, ma è stato recuperato e riutilizzato per costruire sul costruito (Belardi, 1990). Basta pensare al palazzo Ranghiasci di Gubbio (che ha inglobato un’intera schiera medievale) o al tempio di Minerva di Assisi (trasformato in età rinascimentale nella chiesa di Santa Maria sopra Minerva). Ma più ancora basta pensare al palazzo dello Studium Generale di Perugia, che da sede universitaria è diventata un tribunale e che, in futuro, potrebbe diventare un museo o una biblioteca. Perché la sostenibilità, per noi che siamo figli di Galeazzo Alessi e di Guglielmo Calderini, fa parte della nostra quotidianità.
It is your town: know how to survive it
“Secondo i dati raccolti da Symbola e Unioncamere, la cultura vale oggi il 5,4 per cento della ricchezza prodotta in Italia e offre lavoro a 1,4 milioni di persone. La cultura è in sostanza un fattore trainante e di rilancio per molta parte dell’economia italiana: una leva per rigenerare un paese messo a dura prova dalla crisi. Nel quadriennio 2007-2011 la crescita del valore aggiunto delle imprese del settore della cultura è stata dello 0,9 per cento annuo, più del doppio rispetto all’economia italiana nel suo complesso (+0,4 per cento annuo). Ma il dato più clamoroso è la tenuta occupazionale dell’industria di settore, nonostante la crisi. Nel periodo 2007-2011 gli occupati in cultura sono cresciuti dello 0,8 per cento annuo, a fronte della flessione dello 0,4 per cento annuo del livello di occupazione totale. In sintesi, il saldo della bilancia commerciale del sistema produttivo culturale nel 2011 ha registrato un attivo per 20,3 miliardi di euro, mentre a livello di economia complessiva la bilancia indicava -24,6 miliardi. L’export di cultura, per citare altri dati fondamentali contenuti nel rapporto, vale più di 38 miliardi di euro e rappresenta oltre il 10 per cento dell’export complessivo nazionale […]. Una conferma viene anche dall’esame della capacità attrattiva della cultura rispetto al turismo: nella spesa turistica sul territorio italiano nel 2011, la componente attivata dalle industrie culturali vale il 33,6 per cento del totale ovvero 23,3 miliardi di euro” (Boeri, 2012, pp. 29-30.). Ciò nonostante, le risorse che il nostro paese investe in cultura sono molto scarse. Il che appare ancor più incomprensibile se si valuta che le iniziative culturali sembrano le sole capaci di rivitalizzare i nostri centri storici senza svuotare le già misere casse delle rispettive amministrazioni pubbliche. È il caso, ad esempio, della tredicesima edizione di dOCUMENTA (http://d13.documenta.de/), svoltasi a Kassel tra il 9 giugno e il 16 settembre 2012: in 100 giorni, oltre 160 artisti provenienti da 55 paesi hanno presentato le loro opere e hanno espresso le loro idee nei campi dell’arte, della politica, della letteratura, della filosofia e della scienza. Ma è anche il caso di Piano City 2012 (http://www.pianocitymilano.it), svoltosi a Milano tra l’11 e il 13 maggio 2012: una maratona musicale di circa 200 concerti di pianoforte in tre giorni (negli appartamenti, negli studi, nei cortili, nei musei e nelle biblioteche) resa possibile da un appello che ha coinvolto tutti i pianisti di Milano (concertisti, maestri, dilettanti) invitandoli a eseguire un pezzo e da un sito web che ha coordinato le prenotazioni di un pubblico che, girando per la città, si è costruito un programma personale. Ed è proprio sulla falsariga dei precedenti di Kassel e di Milano che è stato attivato Kultur-Fabrik-Perugia: un progetto di ricerca cofinanziato da ANCE Umbria insieme alla Camera di Commercio di Perugia e condotto dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia che, prendendo le mosse dagli esiti di due workshop universitari organizzati in occasione di “Festarch 2012” (“Maratona d’Architettura. P3: Perugia Parasite Project”, promosso dall’Università di Perugia, e “Happinessie Perugia. Il mostro della felicità riusa lo spazio”, promosso dal Politecnico di Milano in collaborazione con l’Isia di Urbino) e interpretando l’intero centro storico di Perugia in forma di palazzo, persegue l’obiettivo di individuare, rilevare e recuperare sia tutte le aree sia tutti i contenitori attualmente in disuso presenti al suo interno e di riorganizzarli in una rete di “ambasciate culturali” dedicate ai diversi paesi europei, in modo tale da trasformare l’acropoli perugina in una sorta di “fabbrica della conoscenza e del dialogo” di livello internazionale. In sintonia con altri esempi di rigenerazione urbana: Las Arenas a Barcellona (una plaza de toros trasformata in un vivace centro commerciale-culturale), il Park Hill di Sheffield (promosso da ghetto popolare a quartiere multietnico di tendenza), gli ex magazzini di cacao, tè e tabacco di Amburgo (trasformati nella scintillante Elbphilarmonie) e soprattutto il Granary Buiding di Londra (eletto a sede del Central Saint Martins College of Arts and Design della University of Arts London). In tal senso, il progetto di riceca Kultur-Fabrik-Perugia è previsto articolato in cinque azioni sinergiche. La prima azione consiste nell’individuazione e nel rilievo ambientale delle aree interne al centro storico (piazze, terrapieni, orti e giardini) che presentano l’attitudine a ospitare nuovi spazi pedonali pubblici ipogei (ad esempio: piazza Matteotti, piazza del Drago, piazza Braccio Fortebraccio ecc.). La seconda azione consiste nell’individuazione e nel rilievo architettonico dei contenitori in disuso che risultano strategici e che presentano l’attitudine a essere riutilizzati (ad esempio: ex teatro Turreno, ex cinema Lilli, ex caserma San Bernardo ecc.). La terza azione consiste nella progettazione di una rete di spazi pubblici ipogei capaci di garantire l’accessibilità pedonale diffusa, la riscoperta delle vestigia storico-archeologiche caso per caso presenti e il comfort ambientale anche nelle stagioni climaticamente più sfavorevoli (ad esempio: risalita meccanica della rocca Paolina, sotterranei della cattedrale di San Lorenzo, galleria archeologica del Sopramuro ecc.). La quarta azione consiste nella progettazione di una rete capillare di ambasciate culturali, gestite da associazioni giovanili costituite in accordo con le amministrazioni contaminando la realtà locale con quella europea, in cui le diverse nazioni coinvolte possano rappresentarsi dal punto di vista culturale con modalità espressive e funzionali assolutamente libere (ad esempio: collegamenti multimediali, installazioni commerciali, forme innovative di ospitalità ecc.). La quinta azione consiste nell’ideazione di un’architettura-landmark capace di conferire valore aggiunto, tanto dal punto di vista simbolico quanto dal punto di vista iconico, all’intero programma. La prima e la seconda azione sono in corso di svolgimento nell’ambito dell’attività didattica e di ricerca del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria edile-Architettura dell’Università degli Studi di Perugia. La terza e la quarta azione sono in corso di svolgimento nell’ambito di tesi di laurea elaborate da studenti del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria edile-Architettura dell’Università degli Studi di Perugia impegnati in stage organizzati presso studi tecnici tra i più qualificati delle nazioni europee coinvolte. La quinta azione è in corso di svolgimento nell’ambito dell’attività di ricerca del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia e prevede la trasformazione dell’ex complesso carcerario di piazza Partigiani in uno “smARTvillage” ovvero in un politecnico della creatività giovanile in cui, così come in molte altre città europee, possano convivere formazione, commercio e ospitalità. Perché oggi il problema del centro storico di Perugia, al pari della gran parte dei centri storici italiani, non sta più nelle strategie volte alla tutela, ma nelle strategie volte alla sopravvivenza. Tanto da imporre il ripensamento dello slogan coniato da Yona Friedman nel lontano 1975. Non più It is your town: know how protect it, ma It is your town: know how survive it!
L'amnesia del presente
di Paolo Belardi
in M. Pisani (a cura di), ITALY NOW. Architecture 2000-2010, Edilstampa, 2012
Contrariamente a un preconcetto diffuso quanto infondato, in Umbria non mancano architetture d’autore recenti: dall’asilo d’infanzia di Marco Zanuso a Gubbio alla scuola per geometri di Vittorio De Feo a Terni fino al centro direzionale di Aldo Rossi a Perugia. Opere diverse tra loro, ma accomunate da una fragilità costruttiva che, paradossalmente, è proprio ciò che ne certifica l’identità culturale. Non è infatti irragionevole sostenere che, in Italia, le architetture più rappresentative realizzate negli ultimi cinquant’anni sono state proprio quelle programmaticamente effimere ovvero quelle svincolate dalla rispondenza funzionale e deputate alla veicolazione ideologica. Vengono in mente il Teatrino Scientifico di Franco Purini e il Teatro del Mondo di Aldo Rossi. Così come viene in mente la Via Novissima allestita in occasione della Biennale di Venezia del 1980. Ma soprattutto, tornando in Umbria, vengono in mente il padiglione espositivo della Fiera dell’Antiquariato di Todi (il discusso “Pallone”), ideato da Carlo Aymonino e Paolo Portoghesi all’indomani del tragico rogo di Todi, e l’ex casa famiglia di Bastia Umbra (il famigerato “Cubo”), firmata da Renzo Piano e da Peter Rice: due opere che vantano paternità illustri, ma ormai prossime alla demolizione (l’ex casa famiglia bastiola) o in totale abbandono (i resti del padiglione espositivo tuderte). Mentre varrebbe la pena recuperarle, restaurarle e rivendicarle come parti integranti del patrimonio storico-artistico regionale. Il che, tuttavia, non è avvenuto e non avverrà. Perché il limite di noi umbri in particolare (e di noi italiani in generale) è di vivere senza la consapevolezza di ciò che siamo e di ciò che abbiamo: ancorati al passato e protesi verso il futuro. Ma nella totale amnesia del presente. Non a caso, percorrendo le superstrade dell’Umbria, le opere schiettamente contemporanee sono rarissime. Per il resto, ciò che rimane delle valli umbre è mortificato dai coppi anticati e dagli zampini in legno che campeggiano su buona parte delle nuove costruzioni, camuffandole in guisa d’improbabili casolari rurali. Eppure, anche in Umbria, i tecnici militanti che praticano con profitto un linguaggio figurativo adeguato a tempi in cui viviamo non mancano. Così come non mancano né l’attenzione critica né le occasioni pubblicistiche. Ciò che manca è la fiducia nell’utilità del progettista architettonico. Tanto che, spesso e volentieri, tale figura professionale è vista più come una penalizzazione imposta da un’esigenza normativa seccante che non come un sostegno caldeggiato da un’esigenza culturale sentita. Ma, fortunatamente, ci sono anche segnali incoraggianti. A cominciare dalla sfida al futuro lanciata dalle stazioni del minimetrò di Jean Nouvel a Perugia e dalla chiesa di Massimiliano Fuksas a Foligno. Fino all’epifania di un indizio apparentemente marginale, ma in realtà assolutamente centrale, quale la locandina dell’ultima festa paesana di Sisto. In essa, infatti, l’identità del più popoloso quartiere-satellite di Perugia non ha chiamato in causa l’anomia figurativa della solita chiesetta neoromanica, ma è stata affidata all’eccezionalità figurativa della mediateca di Italo Rota. Il che, per una terra afflitta cronicamente dall’atavica nostalgia per un mondo vernacolare che non c’è più, se non negli spot pubblicitari di stampo nazionalpopolare, non è cosa da poco.
Una lezione insolita
di Paolo Belardi
in V. De Feo, Tre racconti di architettura. Manuale breve per aspiranti architetti, Libria, 2010
Quando mi è stato chiesto di scrivere una prefazione a questo prezioso libello, mi sono sentito terribilmente (quanto credo comprensibilmente) inadeguato. Poi però, superate le remore iniziali, ho provato uno straniante mix di gioia e tristezza. Mi spiego. Ho provato gioia perché, avendo frequentato con una certa continuità Vittorio, ho avuto la fortuna di leggere in anteprima sia le stesure provvisorie dei tre racconti sia alcuni stralci del manuale; anche se, a onor del vero, il mio giudizio non era tenuto in grande considerazione in quanto era ritenuto sfacciatamente riverente. Ho provato tristezza perché, essendo profondamente legato a Vittorio dal punto di vista affettivo, mi risulta tuttora difficile accettare serenamente la sua mancanza. Sono passati molti anni dall’epoca in cui lavoravo nello studio di via Brunetti: eppure, con il cuore, non mi sono mai allontanato da quel tecnigrafo un po’ obsoleto su cui, grazie ai premurosi ragguagli del mio maestro, ho appreso tutto quello che so sull’architettura.
Ovviamente, poi, non ho potuto non ripensare con nostalgia alle lezioni tenute da Vittorio nelle aule crepuscolari dell’ex convento di San Pietro in Vincoli, in cui i pensieri di noi “mancati ingegneri” (come ci beffeggiavano gli altri laureandi) si affrancavano dalle secche paludose della meccanica e spiccavano il volo verso i lidi celesti della composizione, travolti da una dimensione sovrastorica in cui Bernini, Le Corbusier e Stirling si davano la mano e lavoravano insieme allo stesso progetto: quello della continuità storica. Ma soprattutto non ho potuto non ripensare alla sua lezione più insolita, perché rivolta a un solo studente (il sottoscritto) e impartita in un’aula estemporanea (un autobus romano accalcato quanto accaldato). Era l’estate del 1983 e facevamo ritorno a studio dopo un breve incontro in Campidoglio con Carlo Aymonino (che, all’epoca, era assessore al centro storico della capitale), durante il quale Vittorio aveva appreso che il suo progetto per la ricostruzione delle case popolari del Celio in luogo del “buco” di piazza Celimontana (nel cui ambito mi ero dedicato alla lucidatura a china delle piante, mentre i prospetti erano stati appannaggio del pennino fluente di Carla Saggioro) sarebbe rimasto sulla carta a causa del veto imposto dal soprintendente Adriano La Regina, che intendeva trasformarlo in un parco giochi attrezzato con tanto di scivoli e altalene. Così, mentre l’autobus procedeva lentamente (e, nel nostro caso, mestamente) davanti a Ponte Sant’Angelo, Vittorio (che, nonostante il clima torrido, indossava un abito di lino color cachi, contrappuntato cromaticamente dall’immancabile cravatta blu) abbassò improvvisamente il finestrino e m’indicò un vecchio portale (che poi ho scoperto essere parte della casa Bonadies), spiegandomi che si trattava di un’opera realizzata nell’età di mezzo assemblando alcuni ruderi classici di spoglio. Poi, non senza una sottile vena malinconica, smise gli abiti del professore e indossò quelli del padre, confessandomi di sentirsi un po’ in colpa per avermi lasciato in eredità l’handicap dell’onestà intellettuale. E mi anticipò uno dei passi salienti del manuale, laddove, ipotizzando che un giorno fossi chiamato anch’io a “rimpiazzare [...] un qualsiasi edificio crollato, demolito, fatiscente”, mi raccomandò di mettere da parte tutti i suoi insegnamenti e di abbracciare senza indugi la causa dell’ideologia antiurbana, magari proponendo “di sostituirlo con un giardino”: perché, per guadagnare il consenso di una società sempre più propensa a identificare acriticamente attività costruttiva e speculazione edilizia, conviene usare la gomma e non la matita. Anche se questo significa rinnegare le ragioni stesse del fare architettura. Mi consigliò poi di non dedicare troppo tempo all’attività di studio, soprattutto se volta a risolvere senza residui le obliquità planimetriche occasionali. Meglio frequentare i caffè alla moda e i salotti buoni, perché “per godere di un inossidabile successo professionale la via della mondanità è certo la più proficua”, dal momento che consente di familiarizzare con chi, prima o poi, “puoi ritrovarti davanti dietro la scrivania di un ente pubblico o di una soprintendenza”. Quindi tacque, alzò nervosamente il finestrino e si richiuse in se stesso. Fino a quando, sceso alla fermata di piazzale Flaminio e varcata la porta michelangiolesca, si fermò ad ammirare la dirompente visione prospettica del tridente, ricordandomi (o forse ricordando a se stesso per rincuorarsi in qualche modo) che nell’architettura della città non esiste una verità, ma esistono più verità. E soprattutto esistono molte “cose” levigate dalla storia, che l’architetto ha il compito di raccogliere e ricomporre, evitando di sciuparle per smania autoreferenziale. Così come aveva sempre fatto Aldo Rossi, che proprio Vittorio mi ha insegnato ad amare come progettista prima che come scrittore; contravvenendo ancora una volta a un luogo comune abusato anche dagli studiosi più accreditati.
Alla fine di quell’estate ho lasciato lo studio di Vittorio e ho intrapreso la mia strada, forte del viatico di quella lezione insolita, che compendiava “in nuce” sia l’immaginificità ludica (ancorché colta) dei tre racconti sia la dogmaticità ironica (ancorché amara) del manuale. Che ai miei occhi sono sempre sembrati, e sembrano tuttora, un unicum inscindibile. Perché non c’è distanza tra la mutevolezza percettiva della casa visitata da Anna, l’ordinata disposizione simmetrica del buffet allestito dalla signora Vertecchi, l’inafferrabilità simbolica della curva catenaria che corona la facciata disegnata da Giovanni Castelli e l’incalzante sequenza degli aforismi rivolti agli aspiranti architetti. Così come non c’è distanza tra la spazialità dinamica della scuola per geometri di Terni e l’allusività eccentrica della cappella universitaria di Tor Vergata. D’altra parte, al di là della sua proverbiale vena discontinuista, la coerenza di Vitttorio stava nella sua inattualità, che ha pagato a caro prezzo con architetture (troppo) spesso rimaste sulla carta. A cominciare dai municipi di Legnago e di Botticino. E qui il cerchio del mio discorso si chiude. Infatti, poiché “la loro sorte mi commuove” e visto che “il pensiero di tanta perdita mi blocca lo stomaco”, mi sorge il dubbio di non essere predisposto per il mestiere di architetto. Così come sentenzia senz’appello il manuale. Forse è per questo che tanto tempo fa, di fronte alle mie indecisioni di studente sconfortato, Vittorio (che di lì a breve divenne il mio relatore) mi sconsigliò di cambiare facoltà e mi acquietò consigliandomi di completare velocemente gli studi in ingegneria per poi apprendere nel suo studio i segreti del mestiere. Cosa che ho fatto e di cui non gli sarò mai grato abbastanza.
Accumulazioni caotiche
Le ridondanza espressive della periferia
di Paolo Belardi
in R. de Rubertis, A. Soletti, De Vulgari Architectura. Indagine sui luoghi urbani irrisolti, Officina Edizioni, 2000
In un saggio dei primi anni Novanta, Retorica y Arquitectura (1), Josep Muntañola propone un’originale ermeneusi dell’architettura del Novecento, interpretandone i diversi movimenti alla luce delle tecniche stilistiche proprie dell’ars retorica. Nondimeno, dalle pur sapienti correlazioni proposte dall’autore, trapela la sensazione che le figure retoriche puntualmente attribuite a Le Corbusier, Louis Kahn, Robert Venturi, Alvaro Siza, ecc., tendano a eludere gli angusti perimetri della consecutio classica. Quasi che già nel moderno, e quindi nelle sue protesi (postmoderno, decostruttivismo, ecc.), sia contenuto in nuce il germe di quell’insofferenza per le regole consolidate che, a ben guardare, rimane la vera conquista culturale del Novecento. Tuttavia, volendo avallare il parallelo avviato da Muntañola e, quindi, provando a rilevare eventuali analogie tra la sgrammaticata cacofonia del linguaggio parlato contemporaneo e il degrado estetico delle periferie metropolitane, risulta in qualche modo conveniente adottare criteri analitici di tipo strutturalista; assumendo quindi la periferia come “testo” e prendendo le mosse dalle analisi condotte in chiave fenomenologica da Ivan Fónagy sull’evoluzione linguistica in fieri. Secondo Fónagy, infatti, “non può esistere un’opera - di parola e non - priva di struttura interna” (2) e l’organizzazione testuale di qualsiasi forma artistica di questa fine millennio (sia essa letteraria, musicale o figurativa) è ragionevolmente riconducibile a due precise ridondanze espressive, la ripetizione e la tensione-distensione; ridondanze peraltro riferibili ad un’ibridazione di figure retoriche che, contaminandosi vicendevolmente, producono un’ennesima figura, l’accumulazione caotica, sostanzialmente misconosciuta dalla tradizione classica, ma ricca di apparentamenti con l’inclusività onnivora delle periferie contemporanee.
di Paolo Belardi
in R. de Rubertis, A. Soletti, De Vulgari Architectura. Indagine sui luoghi urbani irrisolti, Officina Edizioni, 2000
In un saggio dei primi anni Novanta, Retorica y Arquitectura (1), Josep Muntañola propone un’originale ermeneusi dell’architettura del Novecento, interpretandone i diversi movimenti alla luce delle tecniche stilistiche proprie dell’ars retorica. Nondimeno, dalle pur sapienti correlazioni proposte dall’autore, trapela la sensazione che le figure retoriche puntualmente attribuite a Le Corbusier, Louis Kahn, Robert Venturi, Alvaro Siza, ecc., tendano a eludere gli angusti perimetri della consecutio classica. Quasi che già nel moderno, e quindi nelle sue protesi (postmoderno, decostruttivismo, ecc.), sia contenuto in nuce il germe di quell’insofferenza per le regole consolidate che, a ben guardare, rimane la vera conquista culturale del Novecento. Tuttavia, volendo avallare il parallelo avviato da Muntañola e, quindi, provando a rilevare eventuali analogie tra la sgrammaticata cacofonia del linguaggio parlato contemporaneo e il degrado estetico delle periferie metropolitane, risulta in qualche modo conveniente adottare criteri analitici di tipo strutturalista; assumendo quindi la periferia come “testo” e prendendo le mosse dalle analisi condotte in chiave fenomenologica da Ivan Fónagy sull’evoluzione linguistica in fieri. Secondo Fónagy, infatti, “non può esistere un’opera - di parola e non - priva di struttura interna” (2) e l’organizzazione testuale di qualsiasi forma artistica di questa fine millennio (sia essa letteraria, musicale o figurativa) è ragionevolmente riconducibile a due precise ridondanze espressive, la ripetizione e la tensione-distensione; ridondanze peraltro riferibili ad un’ibridazione di figure retoriche che, contaminandosi vicendevolmente, producono un’ennesima figura, l’accumulazione caotica, sostanzialmente misconosciuta dalla tradizione classica, ma ricca di apparentamenti con l’inclusività onnivora delle periferie contemporanee.
Ripetizione
L’ars retorica presenta molteplici figure capaci di produrre ripetizione: l’anafora, l’epifora, l’epizeusi, ecc. Ma sono soprattutto la geminatio (“figura che consiste nella ripetizione di una parola o di un gruppo di parole in qualsiasi parte del testo” (3)) e il polittoto (“figura [...] per la quale una stessa parola è usata a breve distanza in funzioni diverse” (4)) a tradire più d’una assonanza con l’atopia delle periferie contemporanee; laddove vere e proprie “architetture-Dolly” sono clonate e distribuite sul territorio con noncuranza per il luogo oltre che per la destinazione d’uso, mentre i medesimi componenti edilizi, in guisa di ready-made di duchampiana memoria, sono chiamati a svolgere funzioni costruttive, e compositive, non necessariamente congruenti con le ragioni originarie. Fino a produrre nuovi sensi e nuovi significati. È il caso dei testi neoscapigliati di Nick Cave (vere e proprie odi al residuale), della House Music (fondata sulla contaminazione di brani musicali eterogenei), delle fotografie di Oliviero Toscani (che rivendicano la bellezza della diversità) o delle coreografie dei Tap Dogs (ritmate dalle percussioni di bandoni di latta, pannelli di compensato, ecc.); parole, sonorità e immagini i cui confini con la soglia del kitsch sono labili, ma che l’uomo metropolitano ha oramai impresse nel proprio Dna.
Ma non è tutto. Nell’ottica della ripetizione, infatti, risultano altrettanto significative l’antitesi e l’enumerazione; laddove l’antitesi (“figura [...] che consiste nell’accostamento di due parole o frasi di senso opposto” (5)) tende a volgere nel contrappunto e nel qui pro quo (un paradosso per cui vengono sovrapposte due interpretazioni antitetiche della stessa situazione), mentre l’enumerazione (“sequenza di parole o di sintagmi congiunti per coordinazione” (6)), se praticata nella forma ironico-sentimentale, carica di plusvalore estetico oggetti apparentemente disomogenei, ma saldati dall’attività nostalgica. Fino a sconfinare nel grottesco (“situazione paradossale deformata dall’ironia” (7)) e nel chiasmo (“disposizione incrociata degli elementi costitutivi di [...] due proposizioni fra loro collegati” (8)). Basti pensare, nel caso del grottesco, agli Ex-voto di Mimmo Castaldi, la cui stravaganza rimanda alla commistione stridente, tipica delle periferie di ogni latitudine, tra feticci vernacolari (staccionate in finto legno, statuette di personaggi disneyani, lampioni in stile floreale, ecc.) e ostentazioni high-tech (antenne paraboliche, allarmi elettronici, pannelli solari, ecc.), tra memorie rurali (filari di viti, orti, ecc.) e reti infrastrutturali (svincoli stradali, centrali elettriche, ecc.); e ancorpiù, nel caso del chiasmo, all’espediente, di retaggio barocco,della “stanza nelle stanza” (9), vera e propria invariante nell’interior design dei centri commerciali e delle attrezzature fieristiche.
Tensione-distensione
Tra le poche figure retoriche in grado di produrre effetti di tensione-distensione, risalta la climax, intesa come “progressione ritmica ascendente” (10), e, conseguentemente, l’anticlimax, ovvero la brusca caduta di tono dell’intensità appena conseguita: una tecnica ricorrente nelle liriche romantiche (il verso conclusivo dell’Infinito di Leopardi), ma frequentata con straordinaria assiduità anche dalla poetica contemporanea; soprattutto nelle malinconiche visioni delle periferie. Vengono in mente i versi di Giuliana Rocchi (Non ci son più le frasche e le betulle/che alla brezza dell’alba/s’inchinavano,/ non ci sono più i canneti/dove noialtri bambini/andavamo a fare i nostri bisogni./Adesso, è tutto luci e cemento), la linea Maginot della tangenziale e degli ipermercati che, forse più della laguna, separano Venezia dal resto del mondo o l’insulso slargo degradato che, nel film Caro Diario, arresta l’escursione in vespa di Moretti nei sobborghi romani. E, con essi, sovviene l’ambiguità prospettica dei centri commerciali in genere, quando tradiscono un equilibrio oltremodo precario tra presenza e assenza: formalmente esuberanti verso la strip, ma monotoni e deludenti nei fronti retrostanti.
Parimenti, le sole altre figure retoriche atte a determinare effetti di tensione-distensione sono riconoscibili nelle combinazioni dell’iperbato (““inversione di alcuni elementi rispetto all’ordine normale” (11)) con la farsa (“mescolanza di motivi diversi finalizzati a un’azione scenica di carattere comico” (12)) e della prolessi (“anticipazione [...] che di solito introduce una frase secondaria” (13)) con l’epifonema (“frase sentenziosa con cui viene concluso, con una certa enfasi, il discorso” (14)).
Nel primo caso (iperbato-farsa), ampiamente frequentato dai pubblicitari, la sospensione improvvisa di un enunciato, o comunque di una situazione pregna di emotività, induce una tensione, al contempo fisiologica e mentale, che è ulteriormente amplificata dalla pausa intercalata (i blancs di Jaques Derrida); soprattutto se quest’ultima è di carattere ludico-ironico (esemplari, in proposito, i proemi dei film di Steven Spielberg, in cui la suspense è puntualmente sdrammatizzata da un’ambientazione frivola), vieppiù se il reiterarsi dell’alternanza iperbato-farsa porta alla definitiva frantumazione della narrazione principale: ciò che in qualche modo si verifica anche nelle periferie, dove i rutilanti grovigli viari sono obliati nei microcosmi caricaturali dei parchi ricreativi (Aquafan, Gardaland, Mirabilandia, ecc.) e delle maxidiscoteche (Aeneas, Baia Imperiale, Fellini, ecc.), mentre il “non finito”, l’interrotto, disegna una texture corpuscolare (15) che nelle ore notturne, così come nelle descrizioni della riviera adriatica di Pier Vittorio Tondelli, dà “l’impressione eccitante di vivere in una metropoli abbandonata e galattica” (16). Laddove in ogni caso “alla base dell’esperienza della frammentazione non sta il dolore per la perdita del rapporto con una totalità cosmica, e nemmeno il rimpianto e la nostalgia di questa - perché - [...] al contrario ciò che anima il frammento è l’entusiasmo per l’affermazione di una singolarità che è capace di spezzare la continuità del mondo” (17).
Nel secondo caso (prolessi-epifonema), invece, la tensione accumulata, in genere indotta dall’indeterminatezza delle anticipazioni, libera un’improvvisa distensione, che restituisce ragion d’essere all’apparente non senso e che, tendendo a chiudere con un aforisma, introduce il concetto di soluzione apicale, di “punta”. Combinazioni retoriche, quelle sopracitate, abusate dall’arte contemporanea (dalle performance del “poeta vandalo” Arman, nelle cui opere gli strumenti musicali sono distrutti e dispersi “nell’atto catartico di ricongiungersi al molteplice e al caos primordiale” (18), al celeberrimo Dark side of the moon dei Pink Floyd, in cui l’infernale sequenza di orologi di Time e l’angosciante frastuono dei registratori di cassa di Money si risolvono nell’algida melodicità di Eclipse), ma riscontrabili anche negli hinterland industriali, dove smisurate teorie di capannoni prefabbricati ostentano esuberanze grafico-gestuali ai limiti del bizzarro (per lo più concentrate in corrispondenza degli ingressi), la cui eccezionalità, piuttosto che riscattare l’anomia seriale dell’intorno, produce un’inquietante sensazione di “stranezza dell’estraneità” che, di per sé, trascende il tradizionale bipolarismo bello/brutto (19).
Accumulazione caotica
Tuttavia il fenomeno linguistico più denso di fermenti innovativi e che, di fatto, avalla il parallelo architettura/retorica anche in ambiente periferico, è l’accumulazione: una “figura retorica - riferibile al connubio climax/enumerazione - che consiste nell’allineamento [...] di oggetti, sentimenti e immagini (anche di tipo inconscio) in modo disordinato o destrutturato”, e che rappresenta, di fatto, “il procedimento stilistico tipico della lirica contemporanea, quando vuole esprimere la condizione sconvolta della psicologia e del mondo attuale”. E l’accumulazione, nella sua accezione di accumulazione caotica, comporta “una mescolanza o rottura dei generi tradizionali (lirico, narrativo, ironico, tragico, ecc.), con effetti inediti di tono e di costruzione metrico-ritmica” (20), che conferiscono dignità all’esperienza di disgusto; un’esperienza decadente, ma straordinariamente contemporanea, che “da un lato è repulsione, presa di distanza dal contaminante, delimitazione di un ambito puro, dall’altro è abiezione, avvilimento e autodegrado, prossimità con l’impuro” (21).
“Che cos’è? Ohhhhh![...] È una r-risatina di sgimbescio e una sghignazzata e uno sguardo di chi se ne frega. Chiedilo a lui se può. Siamo a riposo. Qual’è il motivo della risatina, io non ho motivo della risatina ... Il tipo di domanda eh, me l’hai già chiesto. Oh, quello, oh quello fa ridacchiare tutti quanti; non è buffo? Dovresti farli flettere! Boing! Questo pare orribile? No. Penso che sembri alquanto uh, un nuovo giocherello. penso, io proprio ... Huh? Oh devo lavarmi i piedi; detesto i piedi sporchi con i sandali. Hummmmmmmm”. Così come nelle disarticolazioni lessico-grammaticali di Ondine (il protagonista di un curioso romanzo di Andy Warhol (22), la cui isteria anticipa l’ansietà nevrotica dei personaggi di Woody Allen), l’elenco disorganico rappresenta una pratica irrinunciabile per le avanguardie artistiche di fine millennio (dalla letteratura Trash alla musica Rap, dalla moda Punk alla Crash Art (23)); al pari del linguaggio parlato dalle nuove generazioni (24), la cui anima vitale (così come consacrato da cult-movie come Pulp Fiction di Quentin Tarantino o Trainspotting di Danny Boyle) è per l’appunto l’assemblaggio, veloce e simultaneo, di un “vocabolario transgenetico” (25), farcito di neologismi desunti dal gergo dei mass-media (floppy per “insuccesso”, software per “intelligenza”, bypassare per “superare”, ecc.) o di slogan veicolati dagli spot pubblicitari (“È nuovo?/Lavato con Perlana”, “Silenzio/Parla Agnesi”); neologismi e slogan apparentemente illogici, se intesi isolatamente, ma in realtà costituenti, nell’insieme, uno slang ribelle al tecnicismo criptico dei testi di comunicazione pubblica (avvisi, norme, ecc.), che di per sé rimanda all’insofferenza della periferia per qualsiasi regolamentazione imposta demiurgicamente; soprattutto nelle lottizzazioni abusive, dove il processo edilizio si sviluppa in regime di piena disponibilità territoriale oltre che nella più assoluta anarchia costruttiva. Al punto che “mentre prima il cemento si contrapponeva alla terracotta, il ferro al legno, oggi ininterrottamente si espande una distesa di materiali ibridi e riclicati, al cui interno galleggiano, come sopravvissuti a un naufragio, spezzoni di antiche murature” (26). Ciò che ne risulta è un grumo di accostamenti improbabili (la villetta e il discount alimentare, il depuratore e il vivaio botanico, il circo e il cimitero), in cui la discriminazione gerarchica e l’ordine cartesiano sono soppiantati dalla tolleranza pluralistica e dall’irregolarità labirintica. Nondimeno, “in un’età di aggressiva bruttezza [...] e di squallore come forma d’arte, il caos come meta estetica - non solo - riflette gli atteggiamenti intellettuali e sociali del tempo” (27), ma suggerisce nuovi strumenti ideativi: l’abaco (“riferimento logico per la descrizione degli elementi architettonici, delle loro differenze”) e la serie (“scelta estetica rappresentativa di un ordine analitico, transitorio e frammentario” (28)); fino a produrre soluzioni originali come l’office landscape newyorkese (artefice della distribuzione irregolare dei box per uffici, organizzati in base ai flussi di circolazione naturali) o le immersioni nel cheapscape (“il paesaggio derelitto dei rifiuti, [...] del quotidiano” (29)) della scuola californiana.
D’altra parte, tra la bienséance della costruzione retorica tradizionale e la licenziosità del parlato contemporaneo, sussiste la stessa conflittualità che, nel film The Truman Show di Peter Weir, contrappone implicitamente la soap-lyfe di Seahaven (la soporifera cittadina americana dove scorre placidamente l’esistenza di Truman Burbank) all’impietosità dei suburbi descritti da Walter Prévost o alle solitudini metropolitane dipinte da Edward Hopper. Seahaven, nella realtà, si chiama Seaside ed è un villaggio, fondato dall’imprenditore Robert Davis lungo il litorale nordovest della Florida, in cui, per statuto, le abitazioni si conformano a un pacato stile neovittoriano, mentre tutte le vie principali approdano languidamente in riva all’oceano. Una città ideale, Seahaven-Seaside, che in qualche modo incarna i principi più condivisi del “vivere armonico” borghese; eppure Burbank, presa coscienza dell’inganno, non esita a lasciarsi alle spalle le certezze di un destino preconfezionato, affrontando i rischi di una vita consumata on the road (alla maniera cioè di Jack Kerouac), se non addirittura “eccessiva” (nel senso indicato da Pareyson (30)), ma autentica.
Note
1 J. Muntañola, Retorica y Arquitectura, Madrid 1990.
2 I. Fónagy, La ripetizione creativa. Ridondanze espressive nell’opera poetica, trad. it. di Mario Spinella, Bari 1982, p. 49.
3 A. Marchese, Dizionario di retorica e di stlistica, Milano 1991, p. 133.
4 A. Marchese, op. cit., p. 246.
5 A. Marchese, op. cit., p. 24.
6 G. Barberi Squarotti (a cura di), Dizionario di retorica e stilistica, Torino 1995, p. 104.
7 G. Barberi Squarotti (a cura di), op. cit., p. 164.
8 A. Marchese, op. cit., p. 46.
9 I. Fónagy, op. cit., p. 68.
10 A. Marchese, op. cit., p. 49.
11 A. Marchese, op. cit., p. 152.
12 A. Marchese, op. cit., p. 113.
13 A. Marchese, op. cit., p. 247.
14 A. Marchese, op. cit., p. 101.
15 Cfr. F. Purini, La periferia messa a nudo dai suoi edifici, “Paesaggio Urbano”, 1, 1997, pp. 16-23.
16 P.V. Tondelli, Un weekend postmoderno, Milano 1990, p. 99.
17 M. Perniola, Disgusti. Le nuove tendenze artistiche, Genova-Milano 1998, p. 106.
18 L. Dall’Olio, Arte e architettura. Nuove corrispondenze, Torino 1997, p. 51.
19 Cfr. J.M. Lamunière, Lo strano fra il bello e il brutto. Semiologia e tipologia dell’architettura e dell’agglomerazione, “Paesaggio Urbano”, 3-4, 1994, pp. 8-15.
20 A. Marchese, op. cit., p. 15.
21 M. Perniola, op. cit., p. 18.
22 A. Warhol, a. Un romanzo, trad. it. di P. Meneghelli, Roma 1998, pp. 108-109.
23 Cfr. C. Masi, Cattivo Gusto. Entropie di fine millennio, Bertiolo 1998.
24 Cfr. in proposito E. Banfi e A.A. Sobrero (a cura di), Il linguaggio giovanile degli anni Novanta, Roma-Bari 1992; T. De Mauro, F. Mancini, M. Vedovelli e M. R. Voghera, Lessico di frequenza dell’italiano parlato Milano- Roma 1993; T. De Mauro, Capire le parole, Roma-Bari, 1994; A.A. Sobrero (a cura di), Introduzione all’italiano contemporaneo. Le strutture, Roma-Bari 1998.
25 G. Dorfles, L’arte non tollera la pecora Dolly. Se nasce l’ibridazione estetica, “Corriere della Sera”, 29 gennaio 1999, p. 35.
26 F. Faeta, Le architetture e il cielo. Immagini di un sito post-moderno, in R. Bossaglia, Perifanie. Roma: appunti sul nuovo paesaggio urbano, Roma 1995, p. 18.
27 C. R. Smith, Post-modern e Supermanierismo, trad. it. di D. Lupi Schmid, Roma-Bari 1987, p. 130.
28 F. Leoni, Ragionamenti di architettura, in Le architetture e le strade. Progetti in area suburbana, Roma 1982, p. 34.
29 B. Zevi, Dialetti architettonici, Roma 1996, p. 80.
30 Cfr. L. Pareyson, Ontologia della libertà. Il male e la sofferenza, Torino 1995.
Artefatti insoliti
Dalla quotidianità del deisn anonimo alla vitalità del design involontariodi Paolo Belardi
in P. Belardi, A. Cirafici, A. di Luggo et ali, Artefatti. Fatti d'arte_Fatti ad arte_Fatti ed arte, Artegrafica, 2011
“Il Tapinassi, il vecchio contadino che stava nella casa del Chiasso dove andai a Vivere nel 1976, si era trasferito in una villetta in paese, ma non poteva abbandonare la sua campagna. Così continuava a lavorare i campi sotto la mia casa e in paese, su un terreno abbandonato lungo il fiume, si era costruito un orticello con un allevamento di conigli. Aveva recuperato da una discarica una gran quantità di frigoriferi, ne aveva tolto le porte sostituendole con grate di rete metallica e li aveva impilati l’uno sull’altro. Ne era nato un inedito condominio verticale di sette-otto piani, asimmetrico e sghimbescio, abitato da conigli. Il Tapinassi si arrampicava su una scala a pioli che spostava qua e là per rifornirli di erba fresca e acqua. Alle mie perplessità sulla statica della precaria costruzione e sul trattamento dei conigli mi rispose d’aver costruito una conigliera ideale, perché ‘i frigoriferi sono igienici’. Ora il Tapinassi è morto e qualcuno ha demolito la sua città dei conigli: mi dispiace non averne neanche una foto. Era incredibilmente più bella e vera delle innumerevoli cataste di scatole, minimaliste, trasparenti, più o meno irregolarmente perforate che vedo sulle riviste. Mi dispiace anche di non aver chiesto ai conigli cosa ne pensassero”. Adolfo Natalini (1)
L’uomo è sempre stato artifex e ha sempre cercato di modificare la natura a proprio uso e consumo. D’altra parte ha senso parlare di società e di progresso solo dal momento in cui un essere a statura eretta ha cominciato a produrre quegli artefatti (intesi sia come oggetti fatti d’arte ovvero composti, creati, ordinati, sia come oggetti fatti ad arte ovvero adulterati, contraffatti, manipolati (2) ) che gli hanno consentito di governare un ambiente altrimenti ostile: sfregando un arbusto secco per accendere il fuoco, scuoiando un animale per coprirsi con una pelliccia, sradicando un giunco per costruire un arco. O, con un salto di milioni di anni, premendo un pulsante per avviare un computer. Credo infatti che, dal punto di vista concettuale, non sussista una differenza sostanziale tra la configurazione sfaccettata delle punte delle lance primitive e la forma semipoliedrica degli aerei militari di ultima generazione. Così come credo che non sussista una differenza sostanziale tra l’essenzialità iconica dei graffiti rupestri incisi sulle pareti rocciose delle grotte di Lascaux e il minimalismo espressivo dei codici alfanumerici impressi sulla placca d’oro imbarcata a bordo della sonda Pioneer 10. Casomai, riprendendo un’acuta notazione di Umberto Eco (3), sussistono diverse categorie di protesi escogitate dall’uomo per migliorare le proprie prestazioni fisiche: le “protesi sostitutive” (volte a supplire i deficit funzionali del corpo: bastone, occhiali, cornetto acustico ecc.), le “protesi estensive” (volte a prolungare l’azione naturale del corpo: scodella, cucchiaio, leva ecc.), le “protesi perfezionative” (volte a migliorare le performance del corpo: martello, cavatappi, scala ecc.) e le “protesi magnificative” (volte a consentire azioni altrimenti impossibili per il corpo: ruota, forbici, periscopio). Protesi che peraltro, nel tempo, hanno perso l’originario carattere rudimentale e sono diventate prima strumenti sempre più sofisticati e poi macchine talmente evolute tecnologicamente da consentire il controllo pressoché totale dei processi naturali. Il che ha spinto molti a parlare di “rivoluzione artificiale”. “Come se, con la clonazione, l’allungamento della vita, il trapianto degli organi, la procreazione in provetta, le varie forme del virtuale, stessimo entrando in una nuova stagione della specie, in cui l’artificio ha sostituito la natura" (4). Ma non è così. E, per rendersene conto, basta considerare che gli artefatti che più resistono al passare del tempo sono proprio quelli prodotti dall’Ufficio Tecnico della Natura. Che sono innumerevoli quanto straordinariamente efficienti (se non altro perché hanno superato il difficile collaudo della selezione evoluzionistica): a cominciare dall’arancia e dai piselli, eletti da Bruno Munari a campioni di good design per la distribuzione razionale degli spicchi del primo e per la semplicità d’uso dei secondi (5).
Eppure, nonostante la perfezione degli artefatti prodotti dalla natura, ciò che più mi coinvolge sono gli artefatti, ancorché imperfetti, prodotti dall’uomo. Soprattutto se ispirati dalla necessità. Mi riferisco agli oggetti comuni ovvero a quegli artefatti che, spaziando dalla quotidianità del design anonimo (il cosiddetto Mass Design) alla vitalità del design involontario (il cosiddetto Non Intentional Design), si oppongono idealmente alla sterilità della deriva stilistica in cui rischia di perdersi il design contemporaneo. Provo a spiegarmi con un elenco esemplificativo (ma certo non esaustivo), che chiama subito in causa la stampella, lo stendino, la molletta. Ma anche l’imbuto, la grattugia, lo scolapasta. E ancora la cannuccia, lo stuzzicadenti, il fiammifero. Oggetti semplici, nati in un certo senso da sé, indispensabili per azioni anche minime, ma che tutti adoperiamo senza pensarci troppo su. Conoscendone l’utilità, ma ignorandone la paternità. E la storia. Oggetti rigorosamente no brand, che per lo più affondano le proprie radici nell’età preindustriale, se non addirittura in quella altomedievale (6). Quando cioè, nelle campagne e nelle botteghe delle città murate, i contadini e gli artigiani, costretti dall’indigenza, dovevano ingegnarsi per sopperire all’indisponibilità di prodotti pronti per l’uso, approntando con le proprie mani piccoli capolavori forgiati dal buon senso e dall’essenzialità funzionale. Alcuni di questi oggetti sono ormai pressoché scomparsi, superati dalla velocizzazione della vita e soppiantati dalle innovazioni della tecnica (la lametta da barba, il soffione, lo scaldino) (7). Molti però sono sopravvissuti. Tanto che, ancora oggi, continuiamo a utilizzarli quotidianamente. Penso agli artefatti concepiti per svolgere le attività di pulizia: dalla scopa alla brusca, dalla spazzola allo spolverino. Così come penso agli attrezzi-simbolo (veri e propri emblemi araldici) di alcune categorie artigianali: la pennellessa dell’imbianchino, la sega del falegname, l’incudine del fabbro, l’ago del sarto. Il che non può (e non deve) sorprendere più di tanto. “Il design anonimo – infatti – […] è sempre esistito e per certi versi è un fenomeno extrastorico: oggetti intelligenti prodotti da un sapere diffuso e anonimo che spesso utilizza in maniera innovativa le tecnologie esistenti, creando dispositivi sorprendenti che rispondono nella maggior parte dei casi a funzioni minori e poco esplorate. Questi oggetti sono il segno dell’esistenza di un sapere popolare e diffuso che si colloca al di sotto dei brevetti ufficiali e prima del progetto di un designer. Molti progettisti amano collezionare questo tipo di oggetti, considerandoli come degli archetipi naturali a cui il loro lavoro si ispira – e – molte industrie ne elaborano varianti per sfruttare il patrimonio di intelligenza (o furbizia) che tale tipo di manufatti rappresenta”. D’altra parte, quasi “in polemica con il design colto e ufficiale, gli oggetti anonimi sembrano rappresentare la possibilità di realizzare una sorta di progresso spontaneo che si attua sulla base di una logica di semplicità invece che di razionalità" (8). Logica che peraltro anima anche i geniali campioni di design involontario raccolti con pazienza da Vladimir Archipov nell’ambito di quell’insospettabile laboratorio creativo che si è rivelata la Russia pre-Putin (9). Artefatti casalinghi che meriterebbero tutti indistintamente di essere insigniti con il “Compasso d’Oro a Ignoti” formulato a suo tempo da Bruno Munari (10): aspirapolvere, macchine per cucire, attaccapanni e attrezzi per massaggiare la schiena realizzati con mezzi di fortuna da operai o contadini mossi dalla necessità di sopperire alla cronica carenza di beni di consumo. Perché, come noto, negli anni dell’Urss e della Perestrojka, la vita di tutti i giorni era complicata e la facilità di compimento di operazioni apparentemente banali (come stappare una bottiglia chiusa con un tappo a corona o pulirsi le scarpe prima di entrare in casa) rappresentavano un lusso. Bisognava ingegnarsi. Così un portachiavi a forma di stivale poteva diventare un valido cavatappi, mentre, a loro volta, una serie di tappi a corona montati su un pannello rigido si trasformavano in un comodo zerbino. Archipov è cresciuto in mezzo a queste invenzioni ed è grazie ad esse che, da bambino, ha potuto fare le bolle di sapone con un cucchiaio bucherellato e guardare la televisione con un apparecchio collegato a una ruota di bicicletta montata come antenna. Quando poi ha intuito che la qualità di vita di moltissimi suoi connazionali era dipesa da tali guizzi di genio, Archipov ha cominciato a setacciare le città e (soprattutto) le campagne russe a caccia di oggetti alimentati dall’esistente ovvero prodotti restituendo senso ad artefatti desueti oltre che ricombinando avanzi di artefatti dismessi. Così come facciamo tutti noi quando, di fronte all’impellenza di un problema pratico, rifunzionalizziamo in modo creativo il mondo che ci circonda. Allora “la sedia si trasforma (anche) in guardaroba, in una superficie portaoggetti, in una scala o – ad esempio con dei libri impilati sulla seduta – in una sedia per bambini; i fermagli ben si prestano per la pulizia delle unghie così come per estrarre i CD dal computer; grazie ai magneti, il frigorifero si trasforma in una bacheca; le scale non esistono solo per superare dislivelli, ma allo stesso tempo sono anche panchine e rampe per lo skateboard; i vasetti di marmellata e di senape ospitano matite e penne; le scatole di cartone si trasformano in mensole, il sentiero battuto accorcia la strada" (11).
Gli esempi, sia di design anonimo che di design involontario, sono molteplici e, soprattutto, sono sotto gli occhi di tutti. Basta guardarsi intorno con attenzione e curiosità. Così come hanno fatto i miei studenti del corso di “Laboratorio progettuale di Rilievo dell’architettura" (12), quando hanno riconosciuto, selezionato, misurato e restituito più di duecento artefatti insoliti. Peraltro manifestando un interesse di gran lunga superiore a quello riservato agli artefatti griffati. Forse perché stanchi della distanza frappostasi tra il corpo umano e gli artefatti. Né potrebbe essere diversamente visto che, nell’era dei media elettronici, la gran parte delle opere di design che campeggiano sulle pagine patinate delle riviste specializzate “non ha più da risolvere il problema della forma che segue la funzione, né quello della forma che comunica la funzione – laddove – l’unica vera funzione la svolge il circuito elettronico stampato all’interno: oggetto minimo che non deve comunicare nulla a chi lo usa, perché lo si usa quanto agli effetti, ma non se ne determina il funzionamento, né manualmente né intellettualmente" (13). Mentre sia le opere prodotte dal design anonimo sia le opere riferibili al design involontario sono caratterizzate dalla semplicità d’uso e, soprattutto, dall’imprinting antropomorfo. Il che, in un mondo sempre più artefatto (ovvero popolato da oggetti dettati dalla voglia di stupire con effetti speciali piuttosto che dalla necessità di risolvere problemi concreti (14)), non è cosa da poco.
Note
1 Adolfo Natalini, Il disegno della realtà, in Paolo Belardi (a cura di), DO-IT-YOURSELF. Quando il disegno è sottinteso, Libria, Melfi 2008, pp. 12-13.
2 Cfr. Tomás Maldonado, Arte e artefatti. Intervista di Hans Ulrich Obrist, Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano 2010.
3 Umberto Eco, Artificiale/Mondo Macchina, in “L’Espresso”, 6 gennaio 2005, pp. 58-63.
4 Ibidem, p. 60.
5 Cfr. Bruno Munari, Good Design, Scheiwiller, Milano 1963.
6 Cfr. Chiara Frugoni, Medioevo sul naso. Occhiali, bottoni e altre invenzioni medievali, Editori Laterza, Roma-Bari 2001.
7 Cfr. Laura De Luca, Oggetti smarriti, Simonelli Editore, Milano 2001.
8 Andrea Branzi, Il design anonimo, in Andrea Branzi (a cura di), Capire il design, Giunti Editore, Firenze 2007, p. 48. In proposito cfr. anche Sconosciuti e familiari. Oggetti di design “anonimo” prodotti in Svizzera dal 1920, Hoepli, Milano 1993; Riccardo Giovannetti, Nikolaus Goettsche (a cura di), Oggetti discreti. Un viaggio nel mondo degli oggetti d’autore ignoto, Arte Stampa, Varese 1997; David Lindsay, House of Inventions: the Extraordinary Evolution of Evedriday Objects, Lyons Press, New York 2000; Tonino Paris, Mass Design o il potere dell’oggetto anonimo, in “diid-disegno industriale”, 15, 2005, pp. 4-11; Alberto Bassi, Design anonimo in Italia. Oggetti comuni e progetto incognito, Electa, Milano 2007.
9 Cfr. Vladimir Archipov, Design del popolo. 220 invenzioni della Russia post sovietica, Isbn Edizioni, Milano 2007.
10 Bruno Munari, Compasso d’Oro a Ignoti, in “Ottagono”, 27, 1972, pp. 92-95.
11 Uta Brandes, Michael Erlhoff, Non Intentional Design, daab, Cologne-London-New York 2006, p. 9.
12 Il corso, che è stato attivato nell’anno accademico 2008/’09 dall’Università degli Studi di Perugia nell’ambito del terzo anno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura, ha visto la collaborazione didattica di Marco Armeni, Simone Bori, Luca Martini, Valeria Menchetelli, Francesca Seghini e Marco Palazzeschi.
13 Umberto Eco, op. cit., p. 63.
14 Cfr. Donald Arthur Norman, La caffettiera del masochista. Psicopatologia degli oggetti quotidiani, Giunti Editore, Firenze 1990.
Felix Infortunium
Elogio del fraintendimento creativodi Paolo Belardi
in P. Belardi, A. Cirafici, A. di Luggo et ali, Artefatti. Fatti d'arte_Fatti ad arte_Fatti ed arte, Artegrafica, 2011
“Se sapete disegnare molto bene siete davvero fortunati. Un bel disegno può nascondere un cattivo progetto e, quel che è più importante, anche uno buono.” Vittorio De Feo, Manuale breve per aspiranti architetti, 1995
Come noto, sussistono molte analogie tra la novella La petite maison, pubblicata a Parigi da Jean-François de Bastide nel 1758, e il racconto La casa (e Anna), edito in forma privata (oltre che in un numero limitatissimo di copie) da Vittorio De Feo nel 1991. Sussistono molte analogie perché, come la storia della seduzione della giovane Mélite è strumentale alla descrizione dell’architettura di uno dei padiglioni che, all’epoca della Reggenza, ospitavano gli amori e i piaceri clandestini dell’aristocrazia parigina, così lo svolgersi del corteggiamento di Giovanni nei confronti di Anna è il pretesto per descrivere una casa contemporanea in cui, tuttavia, il debito verso la storia è lampante (d’altra parte la casa di De Feo “è dei nostri anni, come quella descritta da de Bastide era dei suoi…”). Ma sussistono molte analogie anche perché, in entrambe, la scrittura assume un ruolo rappresentativo programmaticamente ambiguo, concedendo ampi margini all’arbitrio dell’interpretazione personale. Il che è stato appalesato dallo svolgimento di una prova extempore che ho assegnato recentemente ai miei studenti del corso di “Rilievo dell’architettura” sulla falsariga di una fortunata iniziativa didattica promossa intorno alla metà degli anni novanta da Marcello Panzarella i cui esiti sono pubblicati nel libro Il progetto di una casa (Palermo 1996). Prova che, grazie alla varietà (ma anche grazie alla vastità culturale) dei riferimenti contenuti nel testo scritto da De Feo, ha consentito di sperimentare la fertile deriva del fraintendimento creativo. L’organizzazione didattica era semplice e il fine didascalico era chiaro: restituire i documenti mongiani canonici della casa (piante, prospetti, sezioni) sulla scorta del solo testo letterario (e quindi in virtù degli indizi compositivi deducibili dalla narrazione), senza l’ausilio dei tre piccoli disegni eseguiti da De Feo a corredo del proprio libello (una pianta, un alzato e un pallido schizzo prospettico). Ciò che ne è scaturito è un bizzarro catalogo di case unifamiliari, inevitabilmente contrassegnate da compenetrazioni oblique e da rotondità occasionali, ma straordinarie proprio perché improbabili. Non a caso, nel passaggio decisivo del racconto di De Feo, Giovanni mostra ad Anna il motto Felix infortunium: “graffito a significare come anche l’accidentale, l’avverso – se si ribaltano i vincoli in virtualità – possano convergere alla costruzione della qualità”. Anche in virtù di quel sano fraintendimento creativo che è proprio di qualsiasi operazione di trascrizione e, soprattutto, quando si tratta di tradurre le parole in segni.
La vitalità delle strade
Dalla via dell’Acquedotto di Perugia alla Circumvallazione esterna di Napolidi Paolo Belardi
in E. Mandelli (a cura di), Il disegno della città opera aperta nel tempo, Alinea, 2003
Per sua stessa natura, un qualsiasi fatto urbano deve necessariamente evolversi come struttura dialettica; secondo cioè continue modificazioni che lo stesso, pur concepito in origine come compiuto, è costretto, se usato, a subire nel tempo. Avviene così che alcune parti di città, crescendo dinamicamente su se stesse, assurgono a un ruolo primario nella geografia urbana non solo in virtù della mera permanenza topografica, ma anche e soprattutto per la complessità, d’immagine e di contenuti, determinata dalle successive integrazioni (1); particolarmente quando queste, dettate dal contingente piuttosto che dalle convenzioni codificate, innescano la trasformazione delle tipologie consolidate in organismi inediti; ancorpiù nelle non rare occasioni in cui il nucleo propulsore dei processi modificatori è rappresentato da una strada, sia essa pedonale o carrabile.
Basti pensare al caso emblematico di via dell’Acquedotto a Perugia (2), parte di un’articolata infrastruttura idraulica che, realizzata nel XIII secolo con lo scopo di rifornire la Fontana Maggiore con l’acqua proveniente da monte Pacciano, ha perso progressivamente la propria funzione originaria fino a trasformarsi, sulla spinta dell’uso quotidiano, in un prezioso collegamento pedonale pensile fra l’area degli insediamenti universitari, il quartiere della Conca e l’acropoli cittadina (tanto da essere dotato, nel 1821, di un parapetto atto a garantire la sicurezza dei passanti). Nel caso di via dell’Acquedotto, infatti, più che la configurazione originaria, ciò che risalta è proprio la contaminazione delle successive modificazioni, lo straordinario intreccio di adiacenze e di sovradiacenze, di arcate murate e di cortine interrotte; il tutto complicato e amplificato da interi corpi di fabbrica aggiunti che, quasi aggrappati al manufatto duecentesco, suggeriscono un ampio repertorio di varianti tipologiche (3). Se isolato, nessuno degli elementi architettonici sopracitati risulta di particolare pregio; neppure, tutto sommato, il manufatto duecentesco (gli archi sono irregolari e le campate non scandiscono un ritmo riconoscibile, mentre la struttura muraria, per quanto restaurata intorno alla metà del XVI secolo da Vincenzo Danti, risulta di modesta fattura). Eppure la straordinaria impressione trasmessa dall’insieme ne convalida la monumentalità; perché via dell’Acquedotto, pur in assenza di un disegno programmatico, presenta una straordinaria unitarietà compositiva, al contempo ricorrente (per le modalità costitutive) e irripetibile (per gli esiti formali), in cui si confrontano, e si integrano, il pubblico e il privato, la scala territoriale e quella architettonica.
Irripetibilità e ricorrenza sembrano quindi costituire altrettanti caratteri che, contestualmente a quello della permanenza, concorrono a saldare in un tuttuno il manufatto architettonico e il luogo di fondazione, le vicende storiche dell’urbs e quelle della civitas, nello specifico l’immagine di via dell’Acquedotto e quella stessa di Perugia. Laddove il carattere dell’irripetibilità è giustificato dalla considerazione che difficilmente, e comunque non senza incorrere in un atteggiamento vernacolare degenere, è possibile concepire unitariamente, cioè con un solo atto progettuale e in un solo tempo, l’assetto formale attuale dell’antica via perugina. Pur pregevoli, ad esempio, né la strada pensile di Por Santa Maria, proposta da Italo Gamberini per la ricostruzione di Firenze, né i percorsi pedonali sopraeleati realizzati da Giancarlo De Carlo nel villaggio Matteotti di Terni presentano una ricchezza e una complessità paragonabili con il precedente perugino; mentre il carattere della ricorrenza rimanda alla tipicità, e quindi alla necessità, di processi analoghi. Infatti, se ad Atrani il viadotto della strada costiera ingloba le abitazioni sottostanti e se a Evora gli alloggi s’incuneano nelle arcate dell’acquedotto romano, le città preindustriali sono spesso caratterizzate dalla tipologia del pont-maison (4). “Un tempo quasi tutti i ponti delle città erano coperti da solidi edifici. Fin verso il Settecento, furono fiancheggiati su entrambi i lati da file di case, alte a volte sino a cinque piani. Era quasi impossibile distinguerle da normali isolati. Ogni tanto un’apertura tra le case permetteva di dare un’occhiata al fiume; se no non ci si sarebbe neanche accorti di essere su un ponte. A Parigi il Pont Notre-Dame, il Pont Saint-Michel e il Pont au Change erano un tempo dei ponts-maisons [...] e il Ponte Vecchio di Firenze è ancora oggi una strada di gioiellieri [...] Il ponte sull’Arno è l’ultimo dei ponts-maisons” (5). Un esempio, quello fiorentino, in cui “le piccole casette che si aggrappano alle campate sull’acqua come rifugi sulle rocce creano una strana confusione, quasi che l’elemento più artificiale (la regola del ponte) si facesse natura mentre le parti più organiche (le casette) divenissero l’elemento architettonico ed artificiale emergente” (6). Purtuttavia, nonostante le evidenti analogie con la tipologia del pont-maison, e con ponte Vecchio in particolare, il caso di via dell’Acquedotto va incluso nella categoria delle strade pedonali pensili, che per lo più rimanda proprio al riutilizzo di infrastrutture idrauliche cadute in disuso. Molteplici peraltro gli esempi tuttora riscontrabili nei centri storici italiani: dall’acquedotto del ponte Canale a Corigliano Calabro (eretto nel XV secolo e convertito nell’Ottocento in un viadotto pedonale che scavalca la sottostante Via Roma) all’acquedotto Mediceo di Pitigliano (edificato nel XVI secolo su progetto di Antonio da Sangallo il Giovane e successivamente inglobato nel Palazzo degli Orsini) fino all’acquedotto di Re Manfredi a Sulmona (che incornicia scenograficamente piazza Garibaldi). E, a ben guardare, la principale peculiarità dell’acquedotto perugino, così come a Corigliano Calabro, a Pitigliano e a Sulmona, risiede proprio nella capacità di regolare i processi di urbanizzazione, catalizzando, se non addirittura condizionando, l’evoluzione morfologica dell’intorno; il che tradisce più di un’analogia con un’infrastruttura apparentemente distante (sia geograficamente che temporalmente), ma in realtà apparentata per la propensione ad assurgere a fattore di addensamento dei processi edificatori e, con essi, di profondi mutamenti morfologici, quale la Circumvallazione esterna di Napoli: un’arteria viaria a scorrimento veloce, realizzata a più riprese tra il 1956 e il 1970 e concepita come collegamento tra le aree orientali (Casoria-Cercola) e quelle occidentali (Lago Patria-Lufrano) dell’hinterland napoletano, lungo la direzione mare-città; un’infrastruttura che peraltro, meglio nota come “doppio senso” (in origine le due carreggiate erano separate da uno spartitraffico continuo di quasi tre metri) oltre che come “strada degli Americani” (perché fu proprio il governo degli Stati Uniti di America a stanziare parte dei fondi necessari per un’infrastruttura indispensabile all’accessibilità della base NATO di Lago Patria) (7), è diventata nel tempo un gigantesco shopping-mall lineare ovvero una variopinta “strada mercato attorniata dalle figure dell’atopia e del fuori scala” (8). Soprattutto a causa dei frequenti, quanto magniloquenti, incroci a raso, intorno ai quali si sono addensati i contenitori atipici prodotti dall’ibridazione tra spazio del commercio e spazio della residenza (9), nonché delle fasce di rispetto che bordano i due lati della strada per una profondità di circa dieci metri, dove si sono insediate innumerevoli attività ambulanti. Ma ancorpiù la singolarità paesaggistica della strada degli Americani è riferibile alla sopraelevata del tratto industriale di Casoria, “che cambia il modo di usare la strada e gli spazi circostanti, sottolinea il taglio nei centri urbani, esaspera l’abitudine alla velocità; sancisce definitivamente il cambiamento di significato della strada e il compromesso raggiunto con l’abitato” (10). Il raddoppio in altezza dell’asse viario, infatti, se da un lato ritaglia aree di margine che tradiscono una conflittualità latente tra la stabilità dei massicci elementi costruttivi dei viadotti (rampe, piloni circolari, travate di acciaio, barriere antirumore ecc.) e la provvisorietà degli elementi minuti propri di una qualsiasi area industriale (manifesti pubblicitari, parcheggi, aree di accumulo, bidoni della spazzatura ecc.), dall’altro definisce una sorta di galleria urbana dove, inferiormente all’impalcato, trovano riparo funzioni tra le più disparate, per lo più alloggiate in container e box prefabbricati. Come a Evora e ad Atrani; ma anche come nel progetto di François Signeur per il recupero dello spazio sottostante allo svincolo Frais-Vallon dell’autostrada tangenziale di Marsiglia (11). In fondo, nonostante lo scarto epocale, sono proprio gli accostamenti improbabili, come quelli di via dell’Acquedotto di Perugia e della Circumvallazione esterna di Napoli, a dimostrare che “è proprio dalla necessità di districarsi tra i vincoli che rasentano l’assurdo [...] che possono scaturire le soluzioni inedite, le invenzioni originali” (12). Forse perché l’anima delle strade (13), da sempre “luogo della luna” (14) (ovvero simbolo della bizzarria e della licenza), è di per sé una straordinaria “camera degli echi delle passioni umane” (15).
Note
Note
1 Secondo Carlo Aymonino la qualità di un qualsiasi fatto urbano è riconoscibile proprio “nella contraddizione esistente fra l’assunto iniziale (il motivo per cui sorse il monumento) e la realtà continuamente mutevole dell’uso che viene fatto di tale eredità (come di tutte le eredità)” (C. Aymonino, Il significato delle città, Roma-Bari 1975, p. 6).
2 Cfr. A. Soletti (a cura di), L’acquedotto medievale di Perugia, Perugia 1992; A. De Felice, L’antico acquedotto della Fonte di Piazza di Perugia. Dal 1254 al 1932, Perugia 1995.
3 Lungo via dell’Acquedotto “il tessuto urbano [...] si presenta molto ‘denso’, avendo quasi saturato i relativi spazi di risulta, e caratterizzato da isolati a blocchi compatti [...] La tipologia esclusiva è quella della schiera che nella maggior parte dei casi ha subito forti trasformazioni interne ed esterne per accorpamenti di lotti originari e/o sopraelevazioni delle preesistenze [...] In generale, comunque, gli edifici costruiti in adiacenza al percorso si caratterizzano per la maggiore complessità tipologica derivante dalle molteplici possibilità di accesso, su più livelli e fronti, dipendente a sua volta dalla funzione pedonale del tracciato. L’originario tipo a schiera è diventato, dopo la pedonalizzazione e a seguito di sopraelevazioni e trasformazioni varie, un ibrido tra il tipo ‘in linea’ nei casi in cui è rimasta una scala interna di collegamento tra i vari piani e quello ‘a ballatoio’, dove tale funzione è espletata dall’acquedotto” (F. Masciarelli, Influenze dell’uso pedonale dell’acquedotto sullo sviluppo tipologico dell’intorno urbano, in A. Soletti, op. cit., pp. 91-92).
4 R. Pefano, Per una storia dei ponti, “Hinterland”, 33/34, 1985, p. 17. Sulla storia dei pont-maisons cfr. anche J. Dethier, Storia e attualità del ponte abitato, “Rassegna”, 48, 1991, pp. 10-19.
5 B. Rudofsky, Strade per la gente, Roma-Bari 1981, pp. 165-167.
6 B. Minardi, Ruderi e rottami-Progetti sovrapposti, “Lotus International”, 32, 1981, p. 89.
7 Cfr. A. Vollaro, Infrastrutture e forma del territorio, Napoli 1999; F. Ippolito, P. Maisto (a cura di), La strada degli Americani, Napoli 2000.
8 R. Lucci, Prefazione, in A. Vollaro, op. cit., p. VIII.
9 Per lo più “non vi è sostanziale differenza tra la forma della casa e la forma dello spazio di vendita, se si eccettua la presenza della cartellonistica pubblicitaria. Fanno eccezione a questo stato di cose i grandi contenitori commerciali che in tempi recenti si sono collocati ai margini della strada: in questo caso la dimensione dell’oggetto, la forma, il carattere dell’involucro hanno un carattere di eccezionalità tale da poter fare a meno del supporto pubblicitario. L’edificio è il simbolo di se stesso, riconoscibile per il colore della facciata o la grafica che spesso ricopre le superfici esterne, identificando l’appartenenza a catene di vendita e a settori morfologici specifici. Le modalità di esposizione del prodotto contraddistinguono il contenitore vetrina dal contenitore scatola e spesso le due tipologie sono compresenti; allo spazio di stoccaggio e al magazzino si affianca l’area destinata alla commercializzazione e alla vendita. L’edificio in questa parte si smaterializza fino al punto da annullare la facciata, trasformandosi in una superficie espositiva aperta su strada: divani, e lampadari fanno bella mostra di sé ai lati delle carreggiate, estroflettendo lo spazio interno ben al di là della parete vetrata. Al contrario, generi alimentari e abbigliamento sono custoditi in duri forzieri di cemento che non alludono minimamente al prodotto, limitandosi a mostrare le insegne luminose di questa o quella catena di supermercati. È possibile ricondurre le figure citate a tre tipi fondamentali, il contenitore, in cui non vi è sostanzialmente relazione con l’esterno, lo showroom o edificio vetrina, dove il tema centrale dell’esposizione del prodotto interessa la gran parte dell’edificio, e il capannone, che a differenza del contenitore ha minori propensioni alla vendita al dettaglio ed assume la forma tipica di luogo di produzione. In vari modi tutte e tre le figure si compongono tra di loro e con la residenza dando origine a complicati insiemi organici che alludono al prototipo del centro commerciale” (C. Finaldi Russo, Appendici, in F. Ippolito, P. Maisto, op. cit., p. 46). Sulle potenzialità espressive della città diffusa cfr. M. Zardini (a cura di), Paesaggi ibridi,Milano 1999.
10 F. Ippolito, La strada degli Americani, in F. Ippolito, P. Maisto, op. cit., p. 10.
11 Cfr. A. Rocca (a cura di), Atlante. Il nuovo paesaggio delle infrastrutture in Europa, “Lotus International”, 110, 2001, p. 138.
12 C. Giammarco, A. Isola, Disegnare le periferie. Il progetto del limite, Roma 1993, p. 95.
13 Cfr. S.Anderson (a cura di), Strade, Bari 1982.
14 G.P. Lomazzo, Trattato dell’arte della pittura, scultura et architectura, VI, Milano 1584, p. 27.
15 B. Rudofsky, op. cit., p. 123.
La rappresentazione della complessità/La complessità della rappresentazione
di Paolo Belardi
in "Paesaggio Urbano", 6 (1995), pp. 59-63
Abstract
Mai come oggi i disegni di architettura tendono a debordare dagli angusti perimetri disciplinari, giungendo a partecipare direttamente alla produzione visiva delle idee e, soprattutto, testimoniando con le proprie “nevrosi grafiche”, spesso deliberatamente enigmatiche ed apparentemente estranee all’architettura rappresentata, il tentativo di restituire un qualche senso estetico alla complessa quanto disorientante frammentarietà del paesaggio urbano contemporaneo.
Un tempo si raffiguravano solo cose che potevamo vedere, o che ci sarebbe piaciuto vedere. Ora invece ci si palesa soprattutto la relatività delle cose visibili, che si manifestano pertanto come un piccolo esempio della totalità del mondo, e delle innumerevoli verità latenti che esso contiene. Le cose ci appaiono in un senso più vasto, moltiplicato, e sembrano contraddire l’esperienza razionale di ieri. Si sta diffondendo una essenzializzazione del casuale (Paul Klee).
La rappresentazione della complessità
Negli ultimi anni il rapporto tra architettura e rappresentazione ha subito profonde modificazioni, indotte non solo dalla progressiva concettualizzazione del dibattito disciplinare (le contaminazioni tra architettura e speculazione filosofica sono sempre più frequenti) o dalle ferree leggi di mercato (la divulgazione pubblicistica dei progetti “obbliga” di per sé l’elaborazione di immagini di grande effetto), ma anche e soprattutto dalla volontà di esprimere in qualche modo quella innegabile complessità della città contemporanea (2) che, al di là delle stranianti disomogeneità che incarnano “il sentimento della tragica differenza tra idealità dell’abitare e realtà metropolitana” (3), appare comunque strutturata da nessi, pur indecifrabili e divergenti, a cui restituire, una volta riconosciuti, nuovi significati e nuove direzionalità.
In verità, in tal senso, già gli anni Sessanta erano stati caratterizzati da alcune pionieristiche esperienze rappresentative (le fotografie di Franco Fontana, i film di Pier Paolo Pasolini, le architetture di Robert Venturi, ecc.) che, scommettendo su ipotesi disgiuntive piuttosto che conciliative, avevano rivelato al grande pubblico la straordinaria vitalità del nuovo ambiente urbano; ma solo in tempi recenti le punte più avanzate della ricerca espressiva, affrancandosi definitivamente da ogni pregiudizio nei confronti della cultura di massa (4), hanno teorizzato una vera e propria estetica del residuale (5) e della rarefazione (6). Soprattutto soltanto in tempi recenti si è giunti a comprendere pienamente come paradossalmente nella città contemporanea, a differenza della città antica, sono proprio le discontinuità a rendere continuo il tessuto urbano (7); vuoti interstiziali ed aree di risulta in cui il punto di vista non è mai statico, ma è mobile e “spostandosi muta il senso della forma addirittura contraddicendolo”, perché “da nessuna parte si trova un centro determinato” (8). Così, con una poetica assolutamente originale, le periferie newyorkesi dei romanzi di David Leavitt sono descritte dall’abitacolo di un taxi, mentre quelle romane di Nanni Moretti sono filmate dal sellino di un ciclomotore.
E, a ben guardare, è proprio la frammentaria struttura policentrica delle nuove espansioni (in cui la composizione non è più governata da un piano univoco, eterno ed immanente) a tradire i limiti impliciti nelle tecniche rappresentative tradizionali. È evidente infatti come le relazioni effimere instaurate tra i singoli episodi (il cui unico codice plausibile è “la variabilità continua dei codici di riferimento” (9)) possano difficilmente trovare una rappresentazione adeguata in un modello relativamente “semplice” come quello bidimensionale mongiano, richiedendo piuttosto modelli iconici innovativi, in grado di avvicinare l’osservatore, in virtù dell’introduzione del fattore dinamico, alla realtà fenomenica effettiva.
La complessità della rappresentazione
Inevitabile quindi che, considerati gli stretti legami che da sempre saldano il binomio disegno/progetto in quell’unità pressoché indissolubile che è l’architettura, un mutamento di pensiero così radicale non incidesse profondamente sugli esiti disciplinari. Non a caso il battesimo del movimento decostruttivista, celebrato da Philp Johnson al Museum of Modern Art di New York nel 1988, è avvenuto in occasione di una mostra la cui carica dirompente era affidata a rappresentazioni che, in nome della trasversalità e della multilateralità (quindi della complessità), tendevano continuamente a debordare dagli angusti perimetri specifici per contaminarsi con altre discipline artistiche.
Ad esempio, così come nell’opera di Frank Gehry l’uso dello schizzo a mano libera oltre che del modello plastico sono pressoché inscindibili dalla scultoreità degli esiti formali (perché il dinamismo delle masse sfalsate e dei solidi sorpresi nell’atto dello scollamento non potrebbe mai essere concepito con rappresentazioni bidimensionali), le aberratissime prospettive a quadro inclinato di Zaha Hadid o le esplosioni assonometriche di Daniel Libeskind e di Bernard Tschumi tendono a rappresentare il processo metamorfico dell’idea prima ancora che l’opera architettonica. Peraltro, se Zaha Hadid affida le proprie istanze rivoluzionarie all’enfasi di disegni raffinatissimi (vere e proprie aeropitture futuriste che infondono l’impressione di un passaggio a grande velocità), nei disegni di Libeskind, ridondanti di oggetti privi di qualsiasi significato convenzionale, si accavallano visioni simultanee dell’edificio riprodotto a diverse scale grafiche e compenetrato da linee ideali (“che evocano l’esperienza mancante o l’equivalente dell’esperienza di un’architettura assente” (10)); mentre gli straniati reperti modernisti di Tschumi, così come nella musica le singole note danno corpo ad una melodia grazie al potere strutturante delle linee dello spartito, trovano la propria ragione costitutiva nelle griglie, fisiche e concettuali, che li ricompongono in un sistema unitario (11). Né d’altra parte le rappresentazioni contemporanee appaiono immuni da influenze riferibili al mondo della cinematografia. Infatti, se l’antica vocazione di sceneggiatore di Rem Koolhaas si estrinseca nella produzione di vere e proprie fiction architettoniche (12), molti dei disegni elaborati dalla Coop Himmelblau (in cui focus and perspective changes, there is a rich repertoire of resting places and viewpoints that bring about stark contrasts of high and low, far and near, narrowness and wideness (13)) richiamano esplicitamente le vorticose sequenze di celebri ambientazioni metropolitane futuribili come in Brazil di Terry Gilliam o come in Blade Runner di Ridley Scott. Ma sono soprattutto le ricerche di Peter Eisenman che, sovvertendo la rigida consequenzialità pianta/prospetto/sezione, destabilizzano di fatto la visione antropocentrica (14), ampliando a dismisura le potenzialità del repertorio formale. Basti pensare esemplificativamente al progetto per il College of Design, Architecture, Art and Planning dell’Università di Cincinnati, laddove la caratteristica matrice geometrica sinusoidale è generata dall’uso sapiente dell’elaboratore elettronico che, replicando all’infinito una linea in perpetua trasformazione, mette implicitamente in discussione i canoni rappresentativi ereditati da almeno quattrocento anni di classicismo latente, prefigurando le nuove frontiere conoscitive di quello che lo stesso Eisenman definisce “spazio ripiegato” (15).
Esperienze, queste del movimento decostruttivista e dei suoi sviluppi (dai Morphosis a Steven Holl, da Elias Zenghelis a Eric Owen Moss), forse disomogenee, certo difficilmente perimetrabili con un giudizio critico lineare ed esaustivo, ma accomunate dalla consapevolezza implicita che, così come le città sono sempre più dissonanti e opprimenti, le immagini che le descrivono non possono certo esimersi dall’esprimere il disagio del vivere contemporaneo, proponendosi anch’esse come stridenti e inafferrabili; soprattutto perché, da sempre, “le immagini e le città si evolvono in maniera parallela” (16). E, evidentemente, la rappresentazione della complessità non può che tradursi nella complessità della rappresentazione (17).
Note
1 “In modi disordinati [...] l’immenso spazio urbanizzato è interrotto da ‘grumi’, coaguli più consistenti costituiti da un ammasso caotico di materiali urbani incoerenti. Volumi ed aree di dimensioni, forma, aspetto, consistenza materica differente; testimoni di esperienze umane e progettuali paratatticamente associate: il condominio, la fabbrica, la casa a schiera, il parcheggio, la scuola, il distributore di benzina, la chiesa, ancora la fabbrica, la cascina, il supermercato, il palazzo per uffici, il parcheggio, l’area di risulta, il campo giochi, l’officina, la grande fabbrica, il deposito degli autobus, il gasometro, il parco urbano, l’attrezzatura sportiva e la discarica. Entro le più diverse forme letterarie elenchi come questo sono divenuti la forma canonica della descrizione di ‘un mondo di oggetti’ che, sino a qualche tempo fa, indicavamo con i termini di ‘periferia’ urbana” (Secchi B., La periferia, in “Casabella” n. 583, 1991, p. 21).
2 “La cultura urbana del nostro secolo si è avvitata intorno ad un asse problematico che si può sintetizzare nello slogan ‘ricomporre i contrasti, sanare le contraddizioni’. Visti i risultati, perché non provare a scommettere su di un’ipotesi che separi di più, che allontani e dissezioni? [...] Cominciamo intanto con il rifiutare la parola città che ormai di senso disciplinare ne ha poco, perché si è caricata di altri e senz’altro più durevoli valori esterni all’architettura” (Purini F., La città tribale, in Leoni F. (a cura di), Le architetture e le strade, Roma 1982, p. 9).
3 De Feo V., Culto dell’antico e sberleffi da metropoli, in “L’informazione”, 5 dicembre 1994, p. 18.
4 “Io sono certo che presto si dovrà riscrivere la storia della cultura e dell’arte di questo secolo o almeno di questa seconda metà: l’arrivo del nuovo millennio, le grandi migrazioni etniche e culturali che ormai rappresentano una realtà inconfutabile [...] imporrebbero sin da ora una radicale rivisitazione storica che ci costringerà a guardare la cultura che stiamo vivendo ed attraversando con occhi diversi” (Politi G., Picasso o Walt Disney protagonista del secolo?, in “Flash Art” n. 189, 1994, p. 17).
5 Cfr. Noel E. (a cura di), Aggiornamenti sull’idea di caso, trad. it. di L. Sosio, Torino 1992.
6 Cfr. Wall A., The disperded city, in Architectural Design n. 108, 1994, pp. 8-11.
7 Wenders W., L’atto di vedere, Milano 1992, p. 90.
8 Formaggio D., La percezione cinestetica. L’occhio mobile e la visione attiva, in D’Alfonso E., Fran E., Estetica tempo progetto, Milano 1990, pp. 107-108.
9 Terranova A., Città sognate, Firenze 1977, p. 118.
10 Libeskind D., Tra metodo, idea e desiderio, in “Domus” n. 731, 1991, p. 18.
11 Cfr. Tschumi B., Projects for Tokyo and Strasbourg, in Architectural Design. Deconstruction II, 1989, p. 13.
12 Cfr. in proposito Cohen J.L., Il ribelle razionale e l’impegno urbanistico dell’Oma, in Lucan J., Oma. Rem Koolhaas. Architetture 1970-1990, Milano 1990, pp. 9-19. Inoltre Maggie Toy, in un suo recente editoriale (Architectural Design n. 11/12, 1994, p. 7), puntualizzando il rapporto tra cinema ed architettura, riporta un’osservazione dello stesso Koolhaas circa la contaminazione fra le diverse attività: There is surprisingly little difference between one activity and the other [...] I think the art of scriptwriter is to conceive sequences of episodes which build suspense and a chain of events [...] the largest part of my work is montage [...] spatial montage.
13 Widman T., Robnik D., Coop Himmelb(l)au. The UFA Cinema Centre: splinters of light and layers of skin, in Architectural Design n. 11/12, 1994, p. 51.
14 Cfr. Falzea M., Il decostruzionismo americano e il testualismo di P. Eisenman, in “Rassegna di Architettura e Urbanistica” n. 78/79, 1993, pp. 161-212.
15 Cfr. in proposito Eisenman P., Oltre lo sguardo. L’architettura nell’epoca dei media elettronici, in “Domus” n. 734, 1992, pp. 17-24.
16 Wenders W., op. cit., p. 88.
17 Cfr. Gianmarco C., Isola A., Disegnare le periferie, Roma 1993, pp. 151-164.
Il disegno della forma urbana
Orientamento e barriere psicologichedi Paolo Belardi
in "Parametro", 193 (1992), pp. 80-81
Al nuovo arrivato la città appare un labirinto. Strade, che egli aveva collocate ben lontane l’una dall’altra, un angolo gliele riunisce ... la città si mette sulla difesa, si maschera, sfugge, inganna, chiama a percorrere i suoi meandri sino all’estenuazione. (1) Walter Benjamin
Che l’anomia della città contemporanea, disegnata più dalla logica del profitto che non da quella che Camillo Sitte definiva magniloquentemente “arte di costruire le città” (2) abbia indotto un progressivo estraniamento, fra l’uomo e l’ambiente costruito, è un fenomeno innegabile. La maggior parte dei tessuti urbani più recenti, infatti, presentano in genere una scarsa intellegibilità, una tale incongruenza fra forma ed impianto da indurre sovente una sorta di disorientamento negli abitanti-utenti che, di fatto, costituisce una vera e propria barriera architettonica generalizzata.
È noto infatti come quella dello smarrimento rappresenti un’esperienza angosciante e come, d’altra parte, la capacità di orientamento (3) intesa come sistema di relazioni istituite tra l’osservatore e l’ambiente circostante (costruito e non), costituisca la ragione stessa dell’immagine ambientale.
Peraltro, riprendendo gli esiti di una lucida analisi psicologico-ambientale di Franco La Cecla (4) appare lecito asserire, pur nei limiti della schematizzazione, che la capacità di orientamento (vale a dire la capacità di far coincidere l’orientamento interiore con quello esterno), ancor più se riferita ad un ambiente costruito, comporta due fondamentali valenze, l’una certa (in quanto fondata su di un processo mnemonico-iconico) e l’altra ipotetica (in quanto fondata su un processo codificante autonomo).
È infatti possibile distinguere due diversi tipi di orientamento:
- un primo tipo di orientamento, inteso come capacità di organizzare un ambiente noto (al limite il proprio ambiente), secondo un sistema di riferimenti iconici memorizzati;
- un secondo tipo di orientamento, inteso come capacità di interpretare un ambiente ignoto, secondo un sistema di riferimenti generali di cui si ipotizza la validità anche nel caso specifico.
In altri termini, nel primo caso l’osservatore, trovandosi in un ambiente anche parzialmente noto, è in grado di orientarsi grazie al riconoscimento dell’identità specifica di quel luogo, vale a dire in virtù dell’autoreferenzialità dei riferimenti percepiti indipendentemente da qualsiasi codice analogico; mentre nel secondo caso l’osservatore, trovandosi in un luogo assolutamente ignoto, proceda per associazione di immagini e di contenuti, intuendo cioè l’organizzazione strutturale dello stesso in virtù della congruenza dei riferimenti percepiti con esperienze maturate in situazioni morfologico-spaziali analoghe. Laddove tuttavia la nozione di riferimento, comprendendo “l’insieme delle indicazioni puntuali esterne all’osservatore” (5) non coincide necessariamente con quella di monumento. Ciò che al contrario appare determinante perché un episodio architettonico assurga al ruolo di riferimento sono invece nel primo caso la singolarità (6) (vale a dire la presenza di un qualche aspetto che, in qualche modo e per qualche ragione, renda lo stesso unico e memorabile), mentre nel secondo il simbolismo (7).
I riferimenti in genere, peraltro, sono più facilmente prescelti come significativi quanto più posseggono una qualche peculiarità d’immagine che, dimensionalmente e formalmente, contrasti con l’intorno (8). In questo senso, evidentemente, assume rilievo l’ubicazione spaziale. Avviene infatti che manufatti architettonici anche ordinari, ma situati in corrispondenza di importanti nodi urbani (in luoghi cioè di percezione intensificata) o comunque spazialmente preminenti rispetto all’intorno, siano memorizzati con facilità e chiarezza, mentre manufatti architettonici anche di pregio, se uniformati lungo un percorso continuo o comunque se non emergenti dal contesto, vengano difficilmente distinti; soprattutto a causa di quel fenomeno sempre più diffuso che Benjamin definisce laconicamente ”percezione distratta“ (9) dell’uomo metropolitano.
Peraltro un riferimento iconico, quindi un qualsiasi segno, appare maggiormente denso di informazioni, quindi significante, quando la veduta è in qualche modo “guidata”. La visione diagonale (che Gordon Cullen definisce sinteticamente “deflessione” (10)) trasmette in genere maggiori informazioni rispetto a quella frontale, così come la direzionalità dei percorsi, e con essa la percezione anticipata dei “punti focali” (11) favoriscono l’orientamento; mentre la presenza di ambiguità morfologiche (ad esempio i “vicoli ciechi” di Martina Franca e di Locorotondo o il “muro” che ha negato a lungo la continuità del tessuto urbano di Berlino) rende il percorso labirintico e, quindi, induce smarrimento. Così come assume particolare rilievo la collocazione del segno in primo piano o sullo sfondo, considerato anche che “la presenza simultanea dei due opposti facilita gli spostamenti” (12).
L’intensità dell’informazione, che comunque dipende necessariamente da alcune variabili caratteristiche del soggetto (cultura, temperamento, status sociale, ecc.), è inoltre accentuata dal numero dei riferimenti potenziali. Paradossalmente infatti sia l’eccesso che l’assenza di informazioni inducono fenomeni di disorientamento: “la pura regolarità conduce ad un crescente impoverimento, ed infine al livello strutturale più basso possibile, che non può più chiaramente distinguersi dal caos, cioè dall’assenza di ordine” (13). Così pure, in un contesto dove ogni elemento risulti “eccezionale”, nulla emerge. In altri termini, così come nel paesaggio naturale, ci si orienta meglio in quegli ambienti edificati in cui sussiste equilibrio tra norma e deroga: nonostante il carattere intricato i centri storici di Otranto e di Spalato, ad esempio, risultano facilmente percorribili proprio perché il calibrato dosaggio di particolari elementi distintivi si presta ad un’organizzazione consequenziale.
Ed il paesaggio urbano contemporaneo sembra avere smarrito queste preziose virtualità, nonostante la necessità delle stesse. Se un tempo, infatti, nella città storica ad ogni segno architettonico corrispondeva un preciso significato cosmico (“l’antico romano sapeva che il cardo lungo il quale camminava era parallelo all’asse intorno a cui rotava il sole, e sapeva di seguire il corso di questo allorché percorreva il decumanus” (14)) o funzionale (le mura urbiche marcavano il confine tra città e campagna, mentre torri, cupole e campanili denunciavano univocamente l’ubicazione dei principali poli della vita cittadina e, con essi, l’articolazione dei quartieri), nelle nuove espansioni solo occasionalmente è possibile rintracciare una tale congruenza tra immagine e contenuto. Così per la toponomastica; nella città storica la nominazione dei luoghi aveva un preciso significato conoscitivo-simbolico, tanto che i toponimi, strettamente correlati alla morfologia urbana, costituivano preziose chiavi di decifrazione della stessa. Vie e piazze, infatti, prendevano il nome dalla località a cui le stesse erano dirette (Avenue Clichy ed Avenue St. Ouen a Parigi, “Via Nomentana”, diretta all’antica Nomentum, a Roma), dalle attività (“Piazza del Mercato” a Lucca, “Via dei Calzaioli” a Firenze), dalla memoria collettiva (nei centri storici italiani tutte le chiese domenicane prospettano su spazi pubblici intitolati a Giordano Bruno), dalle caratteristiche spaziali (“Via delle Volte” a Ferrara, “Via Gradini” a Ragusa), o addirittura dalla stessa configurazione planimetrica (“Via del Sette”, “Via Ritorta” e “Via Scoscesa” a Perugia). Al punto che, a Venezia, la toponomastica fornisce automaticamente una precisa informazione sulla natura del percorso (“fondamenta”, piattaforma sorretta da pali, e “rio-terà”, canale colmato) o sulla gerarchia spaziale (“campo”, “campiello”, “campazzo”), mentre a Genova le “calate” indicano ancora oggi gli accessi al mare.
Note
1 W. Benjamin, Immagini di città, trad. it. di M. Bertolini, Torino 1971, pag.10.
2 Cfr. C. Sitte, L’arte di costruire le città, trad. it. di R. Della Torre, Milano 1981.
3 “L’io si orienta nello spazio in funzione di tre dimensioni, valutando la propria posizione in base ai concetti: sopra-sotto; sinistra-destra; dietro-avanti. Ma poiché le dimensioni spaziali riportate sul piano possono dare adito a notevoli incertezze, nella valutazione tridimensionale altri fattori ausiliari entrano in gioco. Più precisamente, attiva è la tendenza ad orientarsi secondo le dimensioni: maggiore-minore; articolazione grossa-articolazione minuta; chiaro-scuro”. (M. Arnaboldi, Genesi della forma, Venezia 1966, pag. 64).
4 F. La Cecla, Perdersi. L’uomo senza ambiente, Roma-Bari 1988.
5 K. Lynch, L’immagine della città, trad. it. di G.C. Guarda, Padova 1964, pag.93.
6 “Sono proprio le irregolarità che permettono di orientarsi nel dedalo delle strade tutte uguali”. (C. Sitte, op. cit., pag. 165).
7 Cfr. A. Rapoport, The symbolic approach, in The meaning of the built environment. A nonverbal communication approach, BeverlY Hills 1982, pp. 43-48.
8 “Vogliamo invece affermare che un codice totalmente ordinato, privo di qualunque possibilità entropica, risulterà totalmente prevedibile, comunicherà cioè significati assolutamente banali e a tutti noti. Viceversa quell’entropia che dicevamo può aumentare il livello di informazione, è rappresentata da quelle possibilità di disordine del codice, che permette di introdurre nel discorso l’inaspettato, capace di comunicare un qualcosa di originale; un episodio non programmato che, interrompendo la probabilità del codice, riesca ad ampliare le informazioni che il codice stesso solitamente veicola”. (C. De Sessa, Capire lo spazio architettonico. Studi di ermeneutica spaziale, Roma 1990, pag. 167).
9 W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, tr. it. di E. Filippini, Torino 1966, pag. 46.
10 G. Cullen, Il paesaggio urbano. Morfologia e progettazione, trad. it. di R. D’Agostino, Bologna 1976, pag. 181.
11 G. Cullen, op. cit., pag. 18.
12 P. Von Meiss, Dalla forma al luogo, trad. it. di M. De Benedetti, Milano 1992, pag. 167.
13 Cfr. R. Arnheim, Entropia e arte. Saggi sul disordine e l’ordine, trad. it. di R. Pedio, Torino 1974, pag. 68.
14 J. Rykwert, L’idea di città. Antropologia della forma urbana nel mondo antico, trad. it. di G. Scattone, Torino 1981, pag. 261.
Brouillons d'Architects
Una lezione sul disegno inventivo
da Paolo Belardi, Brouillons d'architects. Una lezione sul disegno inventivo, Libria, 2004
da Paolo Belardi, Brouillons d'architects. Una lezione sul disegno inventivo, Libria, 2004
In un breve commento alla raccolta Poesie scritte col lapis, Marino Moretti confessa: “Mentirei se dicessi che tutte queste poesie furono scritte col lapis. Ma oso e amo pensare che nessuno vorrà credere bizzarra e inutile la denominazione complessiva delle mie poesie. Esse meritavano davvero di essere e di restare scritte col lapis: se non altro, il grigio dell’esile matita avrebbe dato loro un colore e un’espressione”. Condivido il traslato di Moretti, che riconduce la labilità della matita alla fragilità della parola, così come avverto molteplici contiguità tra il rammarico per l’indifferenza della modernità verso i valori tradizionali, in cui la poesia ha sempre affondato le proprie radici, e la malinconia con cui oggi molti, tra coloro che hanno vissuto in prima persona la lenta trafila evolutiva degli strumenti da disegno (dal tiralinee al rapidograph, dai tratteggigrafi ai retini letraset), guardano con diffidenza agli spettacolari virtuosismi rappresentativi consentiti dai software di computergrafica. Anche nella mia formazione il lapis, ovvero la matita, ha svolto un ruolo fondamentale. E continua a svolgerlo; se non altro come reperto “araldico” di un mondo artigianale oramai quasi perduto. Ripenso sempre con nostalgia al droghiere della mia infanzia, che declamava a memoria le quantità degli alimenti (“tre etti di reggiano, uno di prosciutto nostrale, due di lardo battuto…”) e d’improvviso, con una rapidità che non aveva nulla da invidiare all’amato Tex Willer, brandiva l’immancabile mozzicone di matita (rosicato, eppure sempre aguzzo), sguainandolo dall’orecchio-faretra e computando direttamente sulla carta paglierina il conto da pagare; con una solennità gestuale che ritrovavo immutata nel fabbro così come nel falegname e nel carpentiere. Queste immagini hanno accompagnato en abyme tutta la mia attività disegnativa e, ogni qualvolta mi sono trovato spaesato di fronte al foglio bianco, ho sempre cercato di debellare l’horror vacui ripensando a quelle formidabili destrezze calligrafiche.
Per queste ragioni, dopo quasi venti anni d’impegno, didattico e di ricerca, nel campo della rappresentazione, ho ritenuto utile provare a fissare una “rete fiduciaria” per il nuovo millennio, dichiarando, senza presunzione di esaustività, il mio punto di vista. Ho quindi redatto una prolusione immaginaria (che cioè non ho mai tenuto e che mai terrò), rivolta agli studenti virtuali di un corso di “Disegno automatico” fittizio quanto pretestuoso (anche se ho più volte ricoperto l’incarico di tale insegnamento); interrogandomi sui destini del disegno manuale nell’era dei media elettronici e, segnatamente, sul ruolo dello schizzo come interfaccia, tra pensiero e opera, nella fase aurorale del progetto. Non so se i riferimenti addotti sono pertinenti e, tanto meno, se l’organizzazione retorica è ortodossa. So però che la tesi sostenuta non è velleitaria, perché molti sensori fanno supporre che, anche nell’era digitale, il disegno a schizzo conserverà intatto il proprio ruolo di pietra angolare della creatività, assurgendo ancor più a forma di pensiero. Non a caso, seppure il testo è punteggiato da continue citazioni e da ripetute allusioni iconografiche, la veste editoriale prescelta, emulando il tono evocativo dei vecchi romanzi d’appendice (che demandavano gli approfondimenti e la visualizzazione dei personaggi alla fantasia del lettore), è priva di note e, soprattutto, di figure. Proprio perché mi stanno a cuore le sorti del disegno-pensiero, sono sempre più sensibile al monito di William Wordsworth: “Basta, col vile abuso delle pagine dipinte! L’occhio sarà ormai tutto, e lingua e orecchio nulla?”
The nursery school "Dr. Senatore Borletti" by Marco Zanuso in Gubbio
di Paolo Belardi
in "area", 146 (2016), pp. 14-21
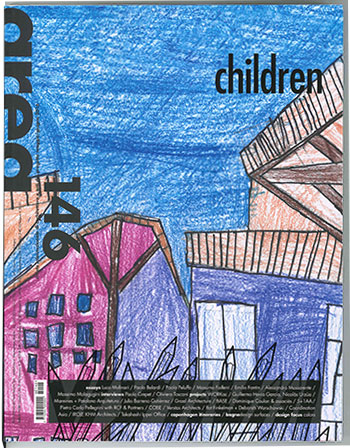

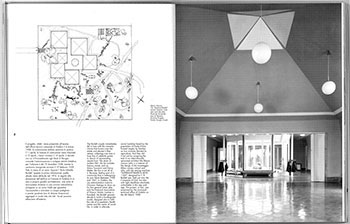
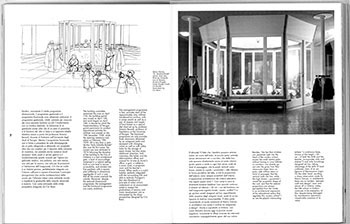
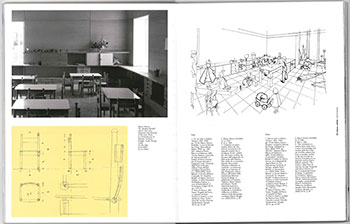
A ben guardare anche I'Umbria, al pari del resto dell'Italia, è punteggiata da edifici scolastici d'autore che, pur appalesando una sensibilità ambientale spiccata e un impegno civile appassionato, sono ormai presi in considerazione solo dal punto di vista dell'adeguamento (antisismico, antincendio ecc.) o dell'efficientamento (energetico, gestionale ecc.), ma sono lasciati completamente a se stessi dal punto di vista della salvaguardia figurativa. Nonostante si tratti di manufatti prossimi alla tutela ope legis. È il caso di molte scuole secondarie, quali l'Istituto Tecnico per Geometri di Vittorio De Feo a Terni e l'Istituto professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato di Franco Antonelli a Foligno. Così come è il caso di molte scuole primarie, quali l'asilo nido di Carlo Rusconi Clerici a San Sisto e la scuola elementare di Paola Coppola d'Anna a Magione. Ma è anche e soprattutto il caso della scuola materna "Dr. Senatore Bori etti" a Gubbio (1): un piccolo edificio scolastico, realizzato nel 1958 nei pressi della frazione di Ponte d'Assi, dove il destino della famiglia Borletti, una delle dinastie industriali milanesi più note e affermate del Novecento, si è incrociato con quello di Marco Zanuso e di Cini Boeri, due grandi protagonisti dell'architettura italiana della ricostruzione. La storia è una storia d'altri tempi, pregna di un illuminismo paternalistico che evoca l'impegno sociale profuso negli stessi anni da Adriano Olivetti a Ivrea. Ma forse è proprio per questo che, in un'epoca indifferente al valore della solidarietà, vale la pena ripercorrerne le tappe salienti. Tutto comincia nella primavera del 1942, quando Senatore Borletti Junior (meglio noto negli ambienti del jet set come Cicci) e sua moglie Nella Cosulich (discendente da una potente famiglia di armatori triestini) stipulano l'atto notarile con cui acquistano dal principe Mario Ruspoli l'azienda agricola di Fassia: una tenuta lussureggiante, composta da ventiquattro poderi, che si estende per quasi 500 ettari a ridosso dei rilievi collinari che perimetrano la conca eugubina in direzione di Perugia e che comprende non soltanto molte case coloniche sparse, retaggio della precedente conduzione mezzadrile, ma anche una grande casa padronale, "riattata" nel 1937 da Nello Baroni e circondata da un parco lussureggiante disegnato da Pietro Porcinai(2) .
l coniugi Borletti s'innamorano subito della climax romantica che aleggia sulla tenuta e la eleggono a buen retiro, collezionando nel tempo una lunga teoria di ospiti celebri alla ricerca di una sosta rigenerante contro "il logorio della vita moderna", nel cui elenco spiccano i nomi di Arturo Toscanini e di Enrico Mattei. Ma non è tutto qui. Perché, sentendosi parte di una comunità che sta riprogettando il proprio futuro (tra il 1956 e il 1961, a Gubbio, l'amministrazione comunale incarica Giovanni Astengo di redigere il suo primo piano regolatore generale e viene fondata l'Associazione Nazionale Centri Storico Artistici), i coniugi Borletti decidono di realizzare un asilo-modello, volto ad assolvere anche il ruolo di centro sanitario pediatrico e di centro di vita associata, nell'intento di alleviare il disagio sociale in cui versa la popolazione di Ponte d'Assi, costituita in gran parte dà nuclei familiari a basso reddito dediti all'agricoltura. E lo fanno non soltanto affidando l'incarico a un architetto di fama internazionale come Marco Zanuso (che è reduce dalla progettazione dell'asilo milanese del Lorenteggio e che con la macchina da cucire "Superautomatica MOD. 11 02", disegnata proprio per la F.lli Borletti spa, ha appena vinto il Compasso d'Oro), ma anche con tempi serrati oggi assolutamente impensabili. Il progetto, infatti, viene presentato all'esame dell'ufficio tecnico comunale di Gubbio il 4 marzo 1958, la commissione edilizia esamina la pratica l'l l aprile, la licenza di costruzione viene rilasciata il 15 aprile, i lavori iniziano il 16 aprile, il decreto con cui il Provveditorato agli Studi di Perugia concede l'autorizzazione a svolgere attività didattica per l'infanzia è del 19 dicembre 1958, mentre la cerimonia inaugurale avviene il 19 febbraio 1959. Tutto in meno di un anno. Eppure l"' Asilo Infantile Borletti" (questa la prima intitolazione: quella attuale viene attribuita nel 1974, in seguito alla donazione dell'edificio al Comune di Gubbio) è un vero e proprio gioiello architettonico: una sorta di micro-paese immerso in una cornice naturalistica, sviluppato su un unico livello per garantire l'accessibilità e articolato in cinque padiglioni a pianta quadrata (ma di diverse dimensioni) aggregati in modo tale che tutti i locali possano affacciarsi all'esterno.
Peraltro, nonostante il ridotto programma dimensionale, il programma gestionale e il programma funzionale sono oltremodo ambiziosi. Il programma gestionale, infatti, prevede per ciascuno dei circa sessanta bambini accolti il trasferimento con un minibus dedicato, la dotazione di un grembiule unisex oltre che di un paio di pantofole e la forni tura del vitto i n base a un'apposita tabella dietetica messa a punto dal professore Antonio Berardi, docente di Pediatria nell'Università degli Studi di Perugia. Mentre il programma funzionale non si limita a prevedere tre aule (disimpegnate da un patio ottagonale e attrezzate con spogliatoi oltre che con casellari per il deposito delle calzature di ricambio), ma prevede anche numerosi locali accessori: tanto usuali (i servizi igienici e il locale-direzione) quanto inusuali per l'epoca (un gabinetto medico, una palestra, una sala mensa, una sala per la musica, una sala per le proiezioni e l'abitazione dell'insegnante). Ciò che ne risulta è un habitat gioioso, perfettamente integrato con l'intorno collinare e capace d'incarnare il principio pizzigoniano (ma anche montessoriano) della scuola per l'infanzia intesa come ambiente vocato a rispettare la gradualità della crescita sensoriale e motoria. Così come anticipato dalle nitide prospettive disegnate da Cini Boeri. D'altronde "il fatto che i bambini possano entrare subito nel cuore dell'asilo, al piccolo poti o centrale, senza attraversare atri o corridoi, che dalle loro aule possano direttamente uscire sul prato intorno [prato aperto e verde su ogni lato senza scale né limiti di passaggio), che le pareti verticali siano basse, mentre le cupole- piramidali- alte rilevano la forma proiettiva del tetto, e che le proporzioni dell'esterno siano sempre avvertibili dall'interno, è espressione architettonica del criterio educativo che regola questo asilo"(3). Così come lo sono la divertente boiserie [laddove "uno zoccolo continuo e sempre ad altezza- 50 cm -sia del bambino sia dell'insegnante ingloba lavabi, ripiani, scaffali"(4)) e gli spiritosi arredi disegnati ad hoc approfittando della maestria degli artigiani locali, eredi di un'ars lignaria di matrice rinascimentale. D'altra parte, riprendendo un'acuta notazione di Marco Zanuso, in architettura non esiste il confine tra artigianato e design(5) . Anche e soprattutto in Umbria: così come dimostra ancora oggi la piccola scuola eugubina, nonostante le offese arrecate da interventi manutentivi inspiegabilmente ignari del suo valore.
Note
l. Cfr. Un asilo a Gubbio, "Domus", 362, 1960, pp. 15-24; Marco Zanuso Architetto, a cura di Manolo De Giorgi, Skira editore, Milano 1999, pp. 244- 247; Valentino Pierini, Rilievo architettonico della "Scuola Materna Comunale Dr. Senatore Borletti" a Gubbio di Marco Zanuso, tesi di laurea triennale in Ingegneria civile, Università degli Studi di Perugia, relatore Paolo Belardi, correlatore Simone Bori, a.a. 2005/2006; Paolo Belardi, La Scuola Materna Comunale "Dr. Senatore Borletti" di Marco Zanuso a Gubbio, in NAU Novecento Architettura Umbria, a cura di Paolo Belardi, Il Formichiere, Foligno 2014, pp. 139-141.
2. Pietro Di Bianco, Villa Fassia. Progetto del Parco, in l giardini di Pietro Porcinai in Umbria, a cura di Marina Fresa, Giulia Giacchè, Luciano Giacchè, Ouattroemme, Perugia 2014, pp. 61-69.
3. Marco Zanuso Architetto/ cit./ p. 244.
4. lvi 1 p. 246.
5. Tapporto sul piano creativo deriva da una serie di conoscenze e di capacità creative che si avvalgono di tutti i sistemi che non hanno confine1 né da parte deWartigianato né dalla parte deWindustria. Tutto quello di cui possiamo disporre deve essere utilizzato a difendere la creatività~~. La notazione/ tratta da un 1 intervista di Ugo Gregoretti a Marco Zanuso neWambito della trasmissione televisiva Lezioni di design/ è pubblicata in Francesca Cigliano/ Marco Zanuso ed Adriano Olivetti. Industrializzazione e progetto/ tesi di laurea magistrale in Architettura/ Politecnico di Milano/ relatore Giulio Barazzetta correlatore Marco Biraghi a.a. 2009/20 l 01 p. 87.
